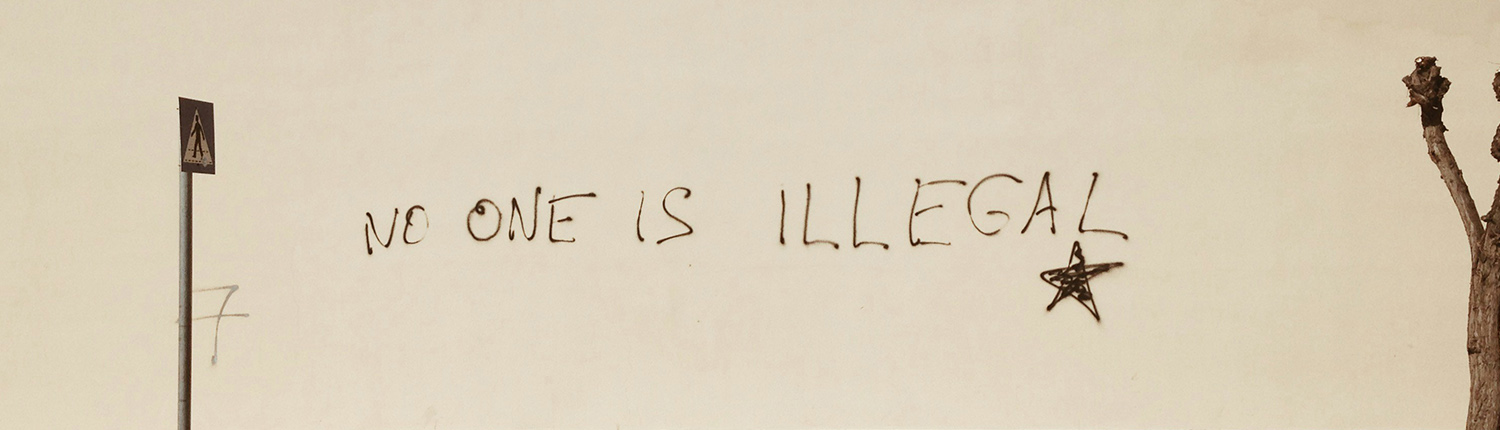Crediti Immagine @CONSCYOU
Di fronte alla rapidità con la quale vengono inserite le nuove collezioni ed eliminate le vecchie, infatti, siamo portati in prima persona ad un adeguamento, che risulta in una sostituzione di quello che possediamo con le novità immesse nel mercato. Diverse le ragioni — stare al passo con la tendenza, massimizzare il piacere di fare qualcosa per sé stessi, rinforzare un bisogno di affiliazione allontanando un sentimento di solitudine, — ma un unico risultato. La sfrenata sovrapproduzione di indumenti e l’eterna questione del loro smaltimento al fine vita.
La rapidità del ricambio delle micro-collezioni e la frenesia della produzione per soddisfare la costante voglia di novità, hanno condotto ad un importante accumulo di rifiuti, con innegabili evidenze di fronte alle immagini delle spiagge della città di Accra, capitale del Ghana, dove giacciono sepolte tonnellate di vestiti usati, ormai sprofondate nella sabbia per metri.
Non è più corretto riferire i vizi di questo mercato alla sola fast fashion: il dominio e il controllo di questo settore è ormai nelle mani dell’ultra fast fashion. Il gigante del settore in questione è un rinomatissimo colosso cinese, che gode di estrema notorietà soprattutto grazie ai social e ai prezzi alla portata di tutti. È dall’idea del fondatore di “rendere la bellezza accessibile a tutti” che si propaga l’idea di un acquisto smodato e continuativo, alla base del nostro comprare senza avere un reale bisogno da soddisfare.
La moda veloce è il sintomo palese di una malattia sociale legata ad un’accelerazione a noi intrinseca, ereditata da un secolo di innovazioni, di rapidità e frenetica velocizzazione dei processi (vedi anche: Il diritto alla lentezza).
Il Riciclo delle fibre tessili
Bisogna ribadirlo, compriamo di più rispetto al passato, è un dato incontrovertibile. Ma non compriamo abbastanza rispetto a quello che viene prodotto, e questo gap tra domanda e offerta produce ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti tessili.
Secondo i dati pubblicati dall’agenzia statunitense per la protezione ambientale (EPA), sarebbe solo il 14,7 percento degli scarti tessili ad essere riciclato. A sottolineare la fragilità di questo sistema è il valore percentuale inverso rispetto a quello sopracitato: per abbattere i costi di smaltimento, molte aziende decidono di termovalorizzare grossi quantitativi del loro dead-stock o, detto più semplicemente, di incenerire lo stock invenduto.
L’unica forma di riciclo naturale è il compostaggio, che consiste nel tentativo di separazione delle fibre sintetiche da quelle organiche sfruttando il processo di degradazione messo in atto da funghi e batteri, dando vita ad un fertilizzante. Un’altra tecnica di riciclaggio delle fibre è la separazione meccanica delle stesse, dalla quale si recuperano nuove fibre sciolte per formare un nuovo filato.
Molto spesso il riciclo delle fibre tessili scartate incontra grossi limiti legati alla separazione dei tessuti multimateriale, e all’impatto che può generare questa pratica: un potenziale bilancio di sostenibilità sarebbe comunque a favore di tecniche di riciclo come la pirolisi anziché della termovalorizzazione o dello smaltimento in discariche all’aperto. La pirolisi permette infatti di ripolimerizzare i monomeri separati dalla rottura della struttura polimerica della fibra, ottenuta dal processo termico.
In conclusione, al primo posto tra le abitudini che richiamano un modello il più possibile sano ed etico per l’ambiente e per l’economia, vi è la riduzione degli acquisti: un radicale cambio di paradigma che insegnerebbe ad acquistare solo ciò di cui si ha bisogno, evitando grossi sperperi di energia e di risorse. Alla riduzione segue la riparazione di indumenti, scarpe e accessori, che potrebbe far diventare la fast fashion una cosa del passato.

Laureata in Scienze Ambientali e studentessa di Environmental Humanities presso Ca’ Foscari. Appassionata di ambiente, di innovazione e di comunicazione.