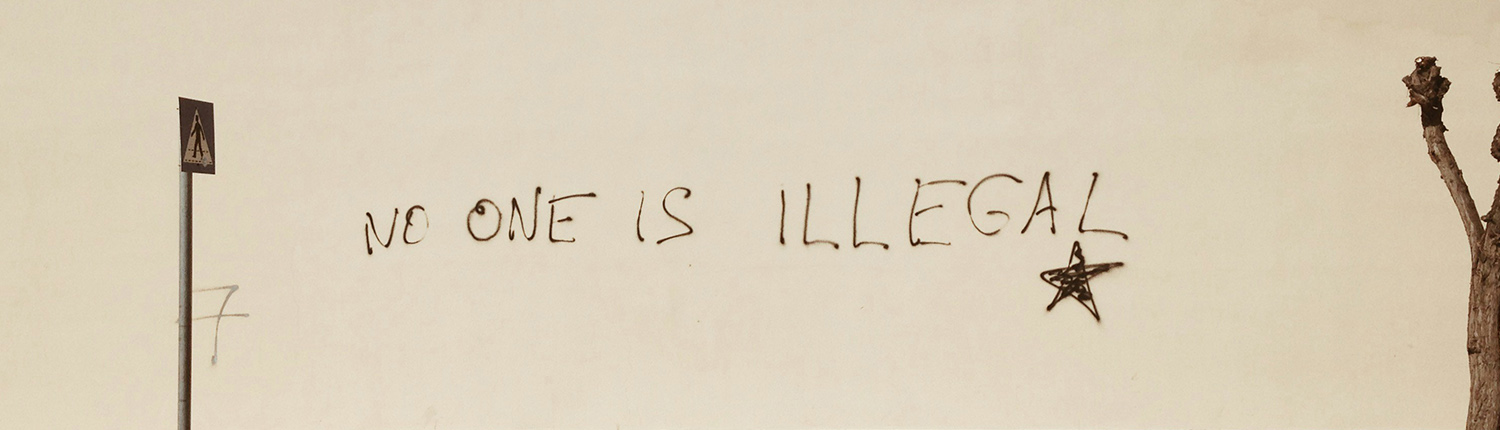Come vengono usati i macchinari per il riciclo della plastica che avete acquistato? È necessaria una formazione specifica per poterli utilizzare?
E.S.: I macchinari acquistati sono tre:
- Shredder, che serve per triturare la plastica.
- Injection, che funziona con un meccanismo a iniezione a pressione: la plastica viene parzialmente fusa e poi inserita negli stampi per produrre oggetti di piccole dimensioni. Non è un processo che produce fumi, non c’è rischio di tossicità, basta dotarsi di un minimo di protezione personale, come guanti e mascherina.
- Extrusion, che con un processo simile permette di produrre oggetti di dimensioni più grandi, principalmente barre (assi, gambe per tavoli,…)
Lascerei però la parola a Carlo, il nostro “artigiano della plastica riciclata”, bravissimo a stampare qualunque tipo di oggetto con gli stampi ottenuti dal nostro produttore.
CARLO DURSO: Principalmente la plastica che ci siamo prefissati di riciclare è l’HDPE, il materiale con cui di solito sono fatti i tappi di bottiglia, sia per motivi di fumi e di gas. Ci manteniamo quindi su una plastica di facile lavorazione e di alta qualità, per il momento; ma puntiamo anche ad allargare un po’ le nostre prospettive, con l’andare del tempo. Per utilizzare i macchinari non c’è bisogno di particolari corsi di formazione, bastano circa venti minuti per capire come funzionano, e poi c’è tanta sperimentazione, soprattutto ora che stiamo cercando di fare oggetti un po’ più grandi. Non c’è un manuale che dice come fare le cose: bisogna provare, fallire, tritare e ritritare. Siamo partiti con lo stampo di una piccola trottolina, il prodotto di un workshop. Ora abbiamo stampi di un frisbee e di un vasetto per le piantine, che si sono rivelati più complessi da fare. Per esempio, si è rivelato necessario l’utilizzo di un fornetto per riscaldare lo stampo, perché la plastica rischiava di raffreddarsi prima di raggiungere la fine dello stampo. L’oggetto finale ha la possibilità di avere poi altre quattro o cinque vite.
E.S.: Esatto, una parte importante è che non ci siano scarti di lavorazione. Abbiamo sempre un occhio alla sostenibilità del processo: non devono essere oggetti usa e getta. Sono comunque oggetti concepiti come gioco, o come decorativi, ma pensati per essere durevoli, non per essere usati pochi minuti e poi gettati via. Lo scopo è evitare che la plastica torni a circolare nell’ambiente. Infatti, la maggior parte della produzione di plastica oggi è proprio quella di prodotti usa e getta, come bottigliette, confezioni delle merendine e sacchetti, che sono anche la maggior parte degli oggetti che trovano nelle spiagge o negli scogli nei nostri clean up.
C.D.: Sì, il monouso è tornato in voga dopo il covid, sicuramente per un’attenzione maggiore all’igiene.
E.S.: Oggi è in corso un cambio culturale forte, ma permane la dispersione dei materiali nell’ambiente. Noi cerchiamo di fare il nostro piccolo per intervenire. Il Lab è strettamente legato alla clean up, non tanto nel flusso produttivo, perché dopo la clean up, grazie alla nostra collaborazione con Veritas restituiamo loro i rifiuti perché vengano smaltiti adeguatamente. La logica che vogliamo trasmettere al volontario è che dal rifiuto può essere creato un oggetto, a cui viene dato un particolare valore.
C.D.: Inoltre non tutte le plastiche possono essere riciclate. Se la bottiglietta rimane a mollo nell’acqua salata troppo tempo, la struttura ne rimane compromessa: è più fragile, si sbriciola. Questo è dovuto anche al passaggio caldo/freddo. La plastica viene denaturata, perde le sue proprietà e non può essere riammessa in un percorso di riciclo.
Quindi la plastica che riciclate è sempre quella che radunate nelle vostre clean up?
C.D.: Non solo. Una volta raccolta si fa una selezione, quello che risulta inutilizzabile lo si usa come monito, durante i workshop, nei quali mostriamo sia la plastica denaturata sia una piccola finestra su quello che in potenza quell’oggetto sarebbe potuto diventare, se non fosse stato disperso nell’ambiente. Il nostro lavoro vuole essere soprattutto quello di creare una catena di sensibilizzazione. A volte, invece, i tappi di plastica ce li portano persone che conoscono l’associazione, per sostenere il nostro laboratorio. Nel nostro piccolo processo, tutti i nostri oggetti sono modellati per poter avere un ciclo di vita lungo. Gli oggetti prodotti non sono commercializzati, il primo che abbiamo realizzato, la trottola, è stato un regalo per i partecipanti a fine workshop, come ricordo dell’attività.
E.S.: Per la gestione dei rifiuti, abbiamo anche fatto diverse consulenze con esperti e vari enti di riciclo in Italia. Una piccola parte della plastica raccolta la utilizziamo appunto a scopo dimostrativo, la maggioranza la restituiamo a Veritas. Lavoriamo anche con i tappi portati dai nostri volontari. L’obiettivo è far capire alle persone il ciclo di vita del prodotto, quali sono i vari tipi di plastica, da dove si origina il problema e quali possono essere le possibili soluzioni Poi questo porta anche a discorsi più ampi relativi alle microplastiche, rilasciate da oggetti che rimangono per mesi, decenni in acqua, per poi entrare anche nella catena alimentare. Un problema che nel Mediterraneo sta ormai diventando endemico.
Con che frequenza fate i workshop? Da chi sono frequentati? Sono aperti a tutti?
E.S.: I nostri workshop sono gratuiti, attualmente siamo in una fase di progettazione per il 2024. Nel 2023 i laboratori erano inseriti nel progetto del bando con il comune: in sei mesi ne abbiamo realizzati cinque, di cui uno diviso in due date.
Ci sono due modi di strutturare il workshop.
La prima è quella che avviene in collaborazione con un partner, come aziende, associazioni, scuole. Inizialmente viene fatto un lavoro di pianificazione, bisogna trovare un partner interessato e un volontario disponibile. Solo determinate persone lavorano toccando i macchinari (come Carlo), siamo tutti volontari e siamo studenti e lavoratori, quindi è necessario incastrare le nostre disponibilità. La seconda è l’“open lab”: il laboratorio viene aperto al pubblico, di solito si fa anche un piccolo evento in cui si spiegano le attività di Venice Calls. In questo modo, le persone possono venire liberamente e se desiderano poi possono anche iscriversi come volontari. L’anno scorso abbiamo alternato questi due tipi di modalità.
L’attività può presentare diversi format a seconda che il pubblico sia più adulto, o composto da adolescenti, o da bambini. Per noi è molto importante il rapporto con le scuole: gli studenti sono i cittadini del futuro, coloro che possono cambiare le sorti della città. L’anno scorso abbiamo fatto un workshop con una scuola francese ed è stato molto interessante vedere come i ragazzi, di quinta liceo, fossero molto partecipativi; hanno apprezzato l’attività proposta e hanno manifestato il loro interesse con molte domande. Abbiamo anche fatto workshop coinvolgendo ricercatori universitari: in quel caso abbiamo dato un taglio più tecnico. È stato bello vedere come lo stesso laboratorio riesca ad accogliere persone con background molto diversi, che però riescono a capire l’urgenza di questa problematica.
C.D.: Sì, è bello come questo lab riesca a “gasare” sia un liceale sia un tecnico.
Come fare parte di Venice Calls? I partecipanti ricevono una formazione, o ci sono dei requisiti?
C.D.: La nostra è una proposta per tutti, ovviamente dipende a che progetto si vuole partecipare e in che maniera. Per esempio, per maneggiare i macchinari, bisogna sapere bene che cosa va fatto, ma è un po’ un’esplorazione anche per noi. Partiamo da ciò che era concepito come un rifiuto, quindi la materia prima è a costo zero. Se anche la trottola viene storta, non importa: è un esperimento. Di solito cerchiamo di affiancare un volontario più esperto a uno nuovo che deve imparare. Facciamo una piccola formazione, in base all’attività che si andrà a fare. Spesso lavoriamo in gruppo, c’è tanto confronto e secondo me si matura parecchio partecipando, sia dal lato progettazione sia da quello delle clean up.
E.S.: Si può iscriversi a Venice Calls anche online, con un form sul nostro sito, dove già durante la compilazione si possono esprimere le proprie preferenze in riferimento alle attività.
Abbiamo possibilità di collaborazione che possono cambiare molto, dalle clean up a coloro che maneggiano i macchinari del lab, per i quali è necessaria un po’ più di formazione. Ci sono poi coloro che si occupano di aspetti di segreteria e di tesoreria.
Potreste dirmi di più sulle clean up?
E.S.: Abbiamo una metodologia molto definita di raccolta, differenziazione e catalogazione dei rifiuti. C’è il volontario che va semplicemente a raccogliere i rifiuti e li porta a un centro di raccolta. Basta che si portino dei guanti, noi forniamo sacchi e pinze. Ci sono poi le persone che si occupano di smistare i rifiuti nei vari cestini, per catalogare ciò che è stato trovato. Per questo è richiesta un po’ di competenza in più.
C.D.: Diciamo che ci sono due fasi. La prima è quella della “formichina” che va a raccogliere i rifiuti indistintamente e poi la seconda è quella del centro di raccolta, dove i rifiuti vengono accumulati su una serie di teli. Altri volontari li suddividono nei vari cestini della carta, della plastica,…
E.S.: Altre associazioni usano metodi diversi, nella nostra esperienza questo è molto efficace, perché ci permette di raccogliere il più possibile. È una doppia attività, perché quando ci si ritrova tutti al centro di raccolta si interagisce con tutti gli altri volontari, si raccolgono così anche i feedback, o anche segnalazioni particolari. Se a qualcuno interessa partecipare, siete invitati alla prossima clean up, che si terrà domenica 17 Marzo, a Sant’Alvise e San Michele, a Venezia, tra le 15:00 e le 18:00.
Grazie per l’invito! Una curiosità: si svolgono sempre sulla terraferma?
C.D.: Interveniamo principalmente in terraferma anche per una questione di inclusione: tra tutti i volontari, non avremmo abbastanza barche in funzione al numero di persone che vengono. Anche se va detto che ogni giro in barca con il nostro presidente si trasforma in una clean up! Raccogliamo quello che troviamo nei canali e abbiamo notato che nei giorni di raccolta della plastica si vedono ogni tanto dei sacchetti pieni che galleggiano. Purtroppo con il trasporto acqueo qualcosa viene disperso.
E.S.: Sì, inoltre dotiamo anche i volontari di retini che ci sono stati dati da donatori privati e che consentono di raccogliere rifiuti in sospensione.
C.D.: Più che in barca, abbiamo utilizzato le barche per portare i volontari a fare delle clean up in luoghi specifici, in zone inaccessibili, a volte non monitorate, al di fuori della giurisdizione di Veritas.
E.S.: Qualche anno fa, per esempio, siamo arrivati a nord di Burano, in una di quelle zone della laguna dove purtroppo i rifiuti si accumulano. Spesso queste sono anche le aree più ricche dal punto di vista naturale, purtroppo. Perciò è necessario che ci siano dei volontari che conoscano bene il territorio, sappiano bene come e dove intervenire. Alcune associazioni internazionali come Sea Shepard hanno collaborato con noi anche per questo motivo: si agisce con delle persone che conoscono il territorio e sanno come agire preservando l’ecosistema.
Dove vi vedete tra cinque anni? Se doveste elencarli, quali sono i risultati quantitativi e di impatto che vorreste raggiungere?
C.D.: Per quanto riguarda il laboratorio, me lo immagino più espanso, con più macchinari, con più capacità di fare cose interessanti e contemporaneamente più radicato nel territorio. Vorremmo avere più collegamenti con università e scuole, collaborare con progettisti per concretizzare prodotti da far fare a bambini nel laboratorio, oggetti che possano essere carichi di significato e che si possano usare sul lungo termine.
A distanza di sei mesi dall’inizio abbiamo ricevuto già diverse mail da parte di studi di diversa natura, per esempio di stampe 3D, esperti di design, ci ha anche contattato un artista americano che ha esposto alla Biennale, quindi abbiamo creato quest’asse Venezia/Detroit che speriamo continui.
Sicuramente i progetti di questi primi sei mesi erano molto pilotati dal bando, ora siamo in una fase di libertà, dove dobbiamo decidere che quali sono le priorità e quale taglio vogliamo dare al laboratorio.
Dal punto di vista di Venice Calls, nel futuro immagino che esista un network tra le associazioni di Venezia per rispondere alle problematiche del territorio nel miglior modo possibile. Questa è una sfida che Venice Calls si è prefissa fin dalla sua nascita: creare coesione sociale.
E.S.: Mi trovo assolutamente d’accordo con Carlo. Tra cinque anni vedo il Lab come una fonte di informazione e di formazione, un punto di incontro dove le persone del settore del design sostenibile si sentano liberi di partecipare e trovino un luogo di sperimentazione. Inoltre, immagino continueremo a fare raccolta di rifiuti, a causa del grave problema dei rifiuti nell’ambiente.
Mi piacerebbe che Venice Calls diventasse sempre di più un network capace di connettere, ottimizzare e contingentare. Un luogo di confronto sociale e culturale, dove i veneziani si sentano liberi di partecipare, incontrarsi, proporre nuove idee. La necessità viene dal fatto che a Venezia molti luoghi per incontrarsi sono diminuiti, per lasciare il posto a supermercati o hotel di lusso. Tra cinque anni, io spero che Venice Calls possa aiutare a invertire quel contatore che c’è a Rialto, dove noi giovani siamo veramente la forza fondamentale per operare questo cambiamento. Servono gli investimenti, serve la politica, ma serve anche che i cittadini di Venezia percepiscano la città come luogo di espressione sociale e culturale.
Edoardo e Carlo hanno voluto condividere quest’ultima domanda con gli altri membri dell’associazione: la risposta qui di seguito esprime la vision della Venice Calls del futuro.
Venice Calls può diventare con l’ impegno dei suoi associati il collettore delle istanze del terzo settore. Una piattaforma per conoscere le persone attive per Venezia. Una associazione in grado di aggregare le realtà più propositive e in grado di portare avanti azioni rigenerative che possano trasformare la percezione dei cittadini della città. In alternativa, resterà attiva per portare avanti progetti educativi per tutti coloro che intenderanno conoscere una porzione della città viva di Venezia. Bandiera di resistenza di un non luogo.

Laureata in Lettere (UniMi), attualmente studia Environmental Humanities (UniVe). Affamata di storie, ama scrivere di ambiente e lasciarsi provocare dalle idee delle persone. Determinata e scrupolosa, le piace andare oltre l’apparente superficialità dei fatti. Il suo luogo sicuro è la biblioteca, ma non fatevi ingannare: non è mai puntuale nella restituzione dei libri.