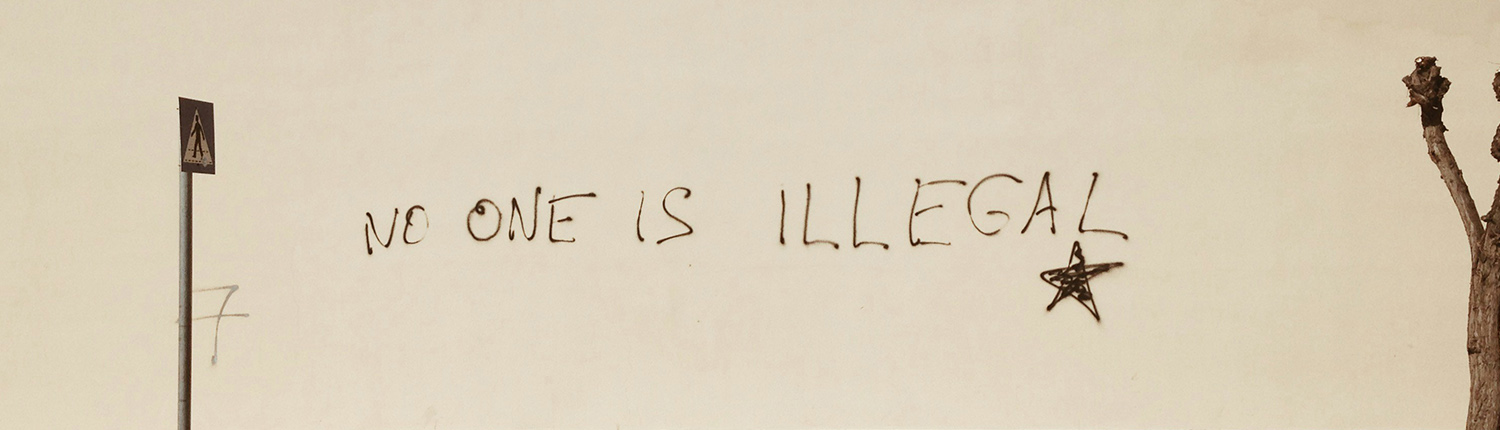La gamification per la conservazione ambientale
La gamification è una tecnica che consiste nell’applicare elementi e dinamiche di gioco a contesti non ludici per raggiungere obiettivi concreti. In altre parole, l’idea è quella di utilizzare i meccanismi tipici dei giochi (ad esempio punti, sfide, ricompense) per scopi diversi dal semplice divertimento. È seguendo questi principi che vengono sviluppati i conservation games, giochi per smartphones a tema conservazione ambientale.
Secondo Chris Sandbrook, professore di geologia della Cambridge University, quando si sviluppano questi giochi, gli obiettivi principali possono essere educare e promuovere comportamenti virtuosi, raccogliere fondi e raccogliere dati utili per la ricerca scientifica.
Un esempio di un gioco per educare è “Aquation: The Freshwater Access Game“, progettato dallo Smithsonian Science Education Center di Washington DC. Questo gioco è stato creato per sensibilizzare e migliorare la conoscenza delle problematiche legate alla conservazione dell’acqua, offrendo ai giocatori una visione globale delle questioni legate alle risorse idriche. I giocatori possono costruire condutture, utilizzare impianti di dissalazione, effettuare ricerche, stabilire politiche e assegnare risorse per garantire che nessuna regione rimanga senza acqua.
Invece, un esempio di gioco sviluppato per raccogliere dati è “eBird”, un’applicazione per smartphone sviluppata nel Regno Unito, che valuta gli utenti in base alla loro accuratezza nell’identificare specie di uccelli, confrontandola con quella degli altri. In questo modo, sfruttando dinamiche competitive, oltre a creare maggior coinvolgimento, si mira ad aumentare la qualità dei dati raccolti.
Il gioco vale la candela?
Negli ultimi anni, c’è stato un crescente ottimismo riguardo le possibilità offerte dalla gamification e ciò ha portato alla creazione di progetti come “Internet of Elephants”, un’azienda keniota specializzata nello sviluppo di giochi per la conservazione. Le stime riguardanti il mercato globale della gamification sono in crescita. Nel 2017, il valore del mercato era stimato intorno a 2,17 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà un volume di quasi 20 miliardi di dollari entro la fine del 2023. Tuttavia, nonostante l’aumento dell’interesse e della domanda per questi giochi, non c’è ancora un chiaro consenso scientifico sulla loro efficacia nel promuovere comportamenti sostenibili tra gli utenti.
Il professor Markus Brauer e il ricercatore Benjamin Douglas, del dipartimento di psicologia della Wisconsin University, in una raccolta di articoli sulla psicologia del cambiamento climatico, sostengono che non abbiamo ancora elementi sufficienti per dare un giudizio chiaro sull’efficacia dei giochi di conservazione. Ad esempio, non si riesce ancora a spiegare in maniera esaustiva perché alcuni giochi funzionano meglio di altri e quali sono i fattori che determinano il loro successo.
Di fronte a questa incertezza, aspettando nuovi dati, gli esperti invitano a non farsi trascinare dall’entusiasmo e considerare anche i possibili rischi della gamification. Il Il professor Chris Sandbrook e colleghi, ad esempio, indicano come possibili rischi quello di semplificare eccessivamente le informazioni che si vuole comunicare, con il possibile effetto di mandare un messaggio distorto della realtà della situazione e il rischio che gli utenti utilizzino il gioco come una via di fuga dal problema reale, a volte proprio in virtù della semplicità con cui viene rappresentata la realtà. Quest’ultimo è sicuramente il rischio principale della gamification: creare un gioco che induce gli utenti a essere passivi, invece che attivarsi per risolvere il problema.
Anche il romanzo di Paolo Stella ci invita a riflettere su questo rischio, mostrandoci un esempio virtuoso (e immaginario) di come usare i giochi per la conservazione ambientale. Nel racconto, i compaesani vengono attratti verso il problema ambientale attraverso un gioco, gli enigmi, il cui risultato è la partecipazione e la creazione di legami sociali con altre persone. Il gioco, in questo caso, è uno strumento efficace proprio perché porta le persone a collaborare e agire, evitando l’isolamento dei giocatori. In una recente intervista abbiamo chiesto a Paolo Stella quale fosse il messaggio più importante del libro. Ha risposto semplicemente: “Partecipiamo, partecipiamo, partecipiamo”.
La gamification e lo sviluppo dei conservation games sono ormai una realtà. Diversi enti di conservazione ambientale già utilizzano questa tecnica e le previsioni sono di un incremento del mercato per questi strumenti. I risultati nell’indurre comportamenti sostenibili sembrano essere più positivi che negativi, ma non è ancora chiara la dimensione e le cause di questo successo. Mentre aspettiamo nuovi dati, è utile considerare il rischio che i giochi allontanino gli utenti dal problema reale, invece che portarli a contrastarlo attivamente. Il libro di Stella ci invita a riflettere sull’importanza dei giochi che inducono le persone a cooperare nella vita reale, lontani dagli schermi di uno smartphone.
In sintesi:
La gamification, traducibile in italiano come “gamificazione”, è una strategia che utilizza elementi e meccaniche tipiche dei giochi per coinvolgere e motivare le persone in contesti non ludici, come l’apprendimento, il lavoro o la conservazione ambientale. L’obiettivo principale della gamificazione è quello di rendere le attività più coinvolgenti, divertenti ed efficaci, incoraggiando le persone a intraprendere determinate azioni o ad adottare comportamenti desiderati.
Nel contesto della conservazione ambientale, la gamificazione può svolgere un ruolo significativo nel coinvolgere il pubblico e promuovere azioni sostenibili per proteggere l’ambiente. Alcuni modi in cui la gamificazione viene utilizzata per la conservazione ambientale includono:
- Applicazioni per la sostenibilità: Sono state sviluppate app mobili che incoraggiano le persone a registrare e monitorare i loro comportamenti sostenibili, come il riciclaggio, l’utilizzo dei mezzi pubblici o il risparmio energetico. Attraverso l’uso di sfide, punteggi e premi virtuali, queste app rendono divertente e gratificante per gli utenti adottare comportamenti eco-friendly.
- Giochi educativi: Sono stati creati giochi educativi che insegnano ai giocatori i principi della sostenibilità, dell’ecologia e della conservazione della natura. Questi giochi possono aiutare a sensibilizzare le persone sulle problematiche ambientali e sugli impatti delle loro azioni.
- Programmi di incentivazione: Alcune organizzazioni utilizzano programmi di incentivazione basati sulla gamificazione per incoraggiare i cittadini a partecipare a iniziative ambientali, come la pulizia delle spiagge o la piantumazione di alberi. I partecipanti possono ricevere ricompense o riconoscimenti per il loro contributo.
- Simulazioni e realtà virtuale: La gamificazione può essere utilizzata per creare simulazioni e ambienti di realtà virtuale che permettano alle persone di sperimentare gli effetti dei cambiamenti climatici o le conseguenze delle azioni umane sull’ambiente. Questo tipo di esperienza può aumentare la consapevolezza e stimolare l’azione.
La gamificazione ha dimostrato di essere efficace nel coinvolgere le persone e nell’incentivare comportamenti positivi per la conservazione ambientale. Aiutando a rendere le tematiche ambientali più accessibili, divertenti e coinvolgenti, la gamificazione può svolgere un ruolo importante nel promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e incoraggiare azioni sostenibili che contribuiscano alla protezione del nostro pianeta.

Dopo la laurea magistrale in filosofia presso l’Università di Padova, frequenta il master di comunicazione scientifica dell’Università di Trento. Attualmente lavora come comunicatore scientifico per fondazioni e centri di ricerca in Italia. Collabora come articolista per Atmosphera Lab.