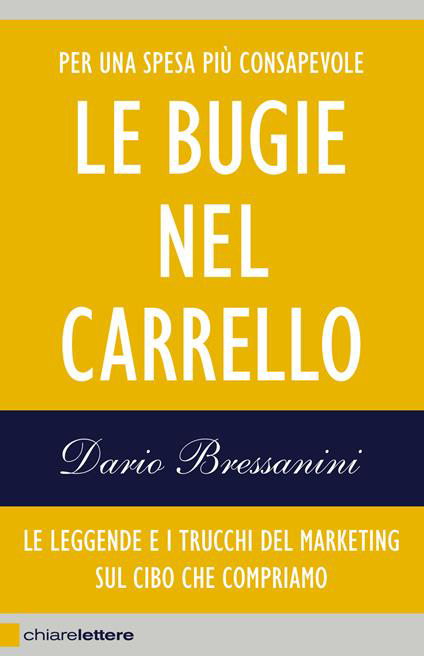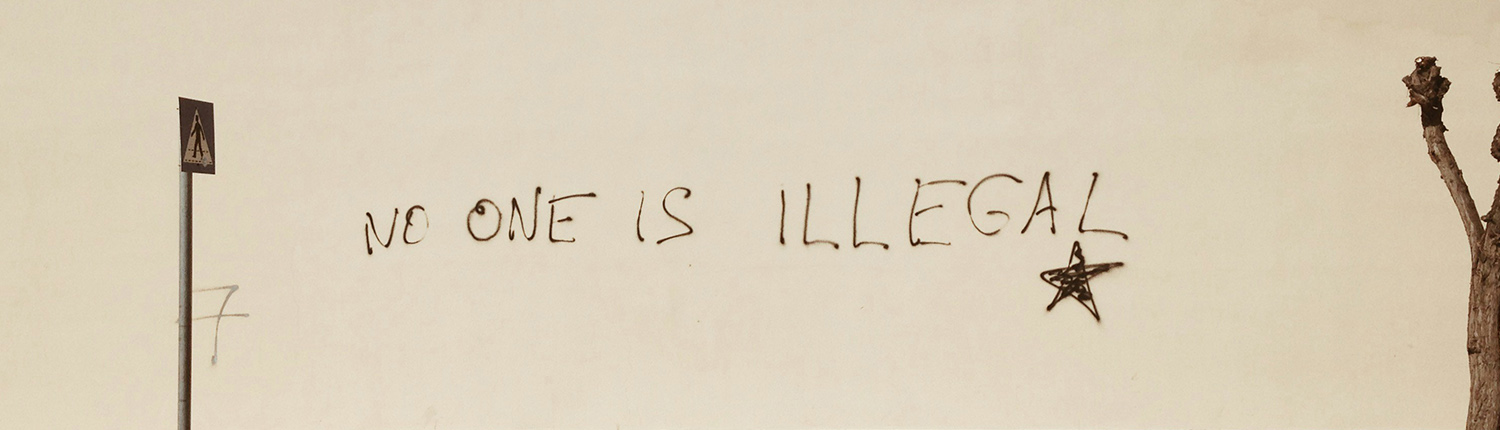L’importanza di scegliere cosa mangiare: tra abitudini e ribellione, tradizioni e attivismo
Il valore che le persone danno al cibo non è assoluto né nel tempo né nello spazio. Ad esempio, la ritualità legata alla pratica del digiuno è vissuta diversamente nelle varie popolazioni del mondo e in alcune è cambiata nel corso dei secoli. Attraverso la rinuncia al pasto si tramandano dei valori, ma all’interno delle popolazioni sono i singoli individui a recepirli e a dare importanza al gesto. La scelta autonoma di accettare o meno alcune norme sociali legate al cibo è fondamentale nel determinare l’entrata di un individuo all’interno della società. Scegliere cosa mangiare è quindi parte del processo di crescita per diventare adulti.
Di conseguenza, non stupisce che sia nel corso dell’adolescenza che molti scelgono di cambiare la propria alimentazione. Durante la crescita, alcuni consolidano le abitudini familiari, a volte rassicurati dal fatto che “è sempre stato così” (anche quando non è vero); altri sfruttano l’occasione per prenderne le distanze. La possibilità di rifiutare la tradizione è il motore del cambiamento in qualsiasi ambito, ma in quello alimentare questa possibilità ha un impatto che si ripercuote con effetto immediato: cosa mangiare da quel momento in avanti.
Il presupposto secondo cui le scelte individuali hanno un effetto tangibile nella vita pubblica è alla base dei movimenti atti alla salvaguardia delle risorse del pianeta, come “Fridays for Future”. Gli attivisti, anche con la loro alimentazione, si fanno promotori di un cambiamento che, in quanto tale, ha un costo per le altre persone. La presenza di una minoranza che mangia diversamente dal resto della comunità spinge il mercato a compiere uno sforzo per assecondarne la domanda. Questo sforzo si concretizza nel momento in cui alcuni prodotti vengono venduti di meno e altri di più; aziende e lavoratori si vedranno costretti a modificare la propria filiera, ridimensionarla e, in alcuni casi, chiuderla (o aprirne una nuova da zero). Scegliere cosa mangiare è quindi un gesto politico, perché influenza la vita pubblica. Il messaggio portato avanti dai movimenti come FFF, che spesso non viene compreso, è che il costo richiesto alla comunità, in questo caso per modificare la filiera alimentare, è minore del costo che comporteranno gli eventi estremi dovuti al cambiamento climatico.
È vero che “Non scegliere è una scelta”?
Mentre la sostenibilità ambientale dei prodotti sta diventando una priorità di chi decide cosa mettere nel carrello della spesa, il Nord America e l’Europa stanno facendo i conti con sempre più persone affette da disturbi legati all’alimentazione. Da una parte le istituzioni promuovono perennemente progetti educativi in tale ambito, dall’altra parte questa situazione può essere una prova a sostegno del fatto che per poter educare su cosa, quanto e come mangiare, è importante considerare anche tutti gli altri aspetti che costituiscono la vita quotidiana di una persona.
Ad esempio: quanto tempo ed energia una persona può investire per informarsi sui prodotti, decidere cosa comprare e cucinare? Nonostante esistano persone che decidono di non scegliere cosa finisce nel loro piatto, è fattuale che con un lavoro a tempo pieno è difficile investire le ore restanti nella propria alimentazione. In alcune condizioni più svantaggiate economicamente, averne il tempo è considerabile come un vero e proprio privilegio difficilmente accessibile. Se si volesse attuare un progetto di educazione alimentare efficace, questo dovrebbe prevedere a priori una condizione sociale in cui tutte le persone hanno a disposizione la medesima quantità di tempo e denaro da poter riservare all’informarsi su come costituire la propria dieta.
Responsabilità e consapevolezza. Storia di un consumatore confuso
Anche qualora un individuo abbia ricevuto un’educazione in merito e disponga delle risorse necessarie, si troverebbe comunque in difficoltà a orientarsi di fronte alla miriade di scelte possibili dentro (e fuori) un supermercato. In ambito alimentare si assiste da parecchi anni a un annacquamento delle informazioni riguardanti il cibo dovuto al marketing. Di questo fenomeno trattano in dettaglio diversi saggi di Dario Bressanini, tra cui Le Bugie nel carrello o il più recente Fa bene o fa male?. Data la crescente disponibilità di informazioni immediatamente fruibili attraverso i media, il consumatore è sommerso da un’infodemia di cui non ha il controllo. A sua tutela, solo le istituzioni (nazionali e sovranazionali) possono dialogare con le aziende e porre dei freni attraverso la legislazione apposita, sia sui prodotti sia sulla loro sponsorizzazione. La responsabilità delle aziende su quali prodotti sono maggiormente consumati (e quindi sul loro impatto ambientale) è molto maggiore rispetto a quella del singolo individuo.
Affermare che sono le grandi compagnie di distribuzione ad avere la responsabilità su cosa viene consumato, può sembrare in contraddizione con quanto riportato in precedenza sull’impatto delle scelte individuali, tema portato avanti dai movimenti come Fridays for future. La chiave di volta sono, anche in questo caso, le istituzioni. Laddove vi siano gruppi di consumatori che attraverso le loro scelte di acquisto manifestano un desiderio di cambiamento, sta alle istituzioni prendersi cura di questi gruppi (solitamente in minoranza) e dialogare con le aziende per soddisfare la nuova domanda. Le certificazioni di prodotti biologici o il marchio Fairtrade® ne sono un esempio. Nel dibattito attuale, le istituzioni devono muoversi in anticipo per regolamentare le nuove fette di mercato alimentare che vanno aprendosi, dal consumo di prodotti proteici derivati dagli insetti a quelli ottenuti dalla coltura in vitro.
Cosa mangiamo definisce chi siamo?
Da quanto detto emerge che attraverso il cibo è possibile avere un’immagine della società nel suo insieme. Di conseguenza il quadro che si presenta è complesso e non vi è un protagonista super partes da cui tutto dipende, ma singoli attori che costituiscono la narrazione: i produttori, le aziende di distribuzione, le compagnie di marketing, le istituzioni, i singoli consumatori con le loro scelte. In un tale contesto, ribadendo la pressante infodemia a cui le persone sono sottoposte, è normale che quest’ultime si sentano schiacciate all’angolo, senza potere decisionale. Per questo motivo diventare consapevoli del funzionamento della filiera alimentare, offre la possibilità di sentirsi nuovamente padroni delle proprie scelte.
Esiste però un lato negativo della medaglia. Nel momento in cui si acquisiscono molte nuove conoscenze, queste possono essere circoscritte in una bolla informativa che oltre alle nozioni (che non sempre sono trasparenti e ben documentate) porta una serie di valori morali in cui è facile riconoscersi. Il rischio è che le persone decidano di seguire una determinata dieta non alla luce delle nuove conoscenze apprese, ma unicamente per definirsi attraverso quella dieta. In questi casi si tende ad adottare il “pacchetto completo” e di rado lo si adegua alle proprie esigenze. Questa fedeltà a quello che diventa letteralmente un “regime alimentare” viene premiata anche mediante l’auto riconoscimento all’interno di un gruppo definito, in cui appunto, identificarsi.
È importante notificare che il connubio fra la ricerca d’identità del singolo e l’infodemia dovuta a un marketing aggressivo – che non lascia spazio alla riflessione personale ma offre sempre più risposte certe – può portare a non riconoscere operazioni di greenwashing o ancor peggio, vere e proprie truffe.
Reference
Daniel L. Rosenfeld, Anthony L. Burrow, The unified model of vegetarian identity: A conceptual framework for understanding plant-based food choices, in «Appetite», 2017, n. 112, pp. 78-95; https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.01.017.
Isobel R. Contento et al., Understanding the food choice process of adolescents in the context of family and friends, in «Journal of Adolescent Health», vol. 38, 2006, n. 5, pp. 575-582; https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2005.05.025.
Dario Bressanini, Le bugie nel carrello. Le leggende e i trucchi del marketing sul cibo che compriamo, Milano, Chiarelettere, 2013.
Elena Colombo, Movimenti giovanili: l’importanza di re-agire. Ecoansia e le sue conseguenze, in «AtmospheraLab»: Movimenti giovanili: l’importanza di re-agire | atmospheralab.com.
Marilynn B. Brewer, The Psychology of Prejudice: Ingroup Love or Outgroup Hate?, in «Journal of Social Issues», vol. 55, 1999, n. 3, pp. 429-444; https://doi.org/10.1111/0022-4537.00126.

Laureato in Biologia Molecolare e in Biologia Evoluzionistica (UniPd), è appassionato di saggistica scientifica.
Si propone ad Atmosphera Lab con l’intento di mettersi alla prova e scrivere di ciò che da sempre muove la sua curiosità: l’ambiente.