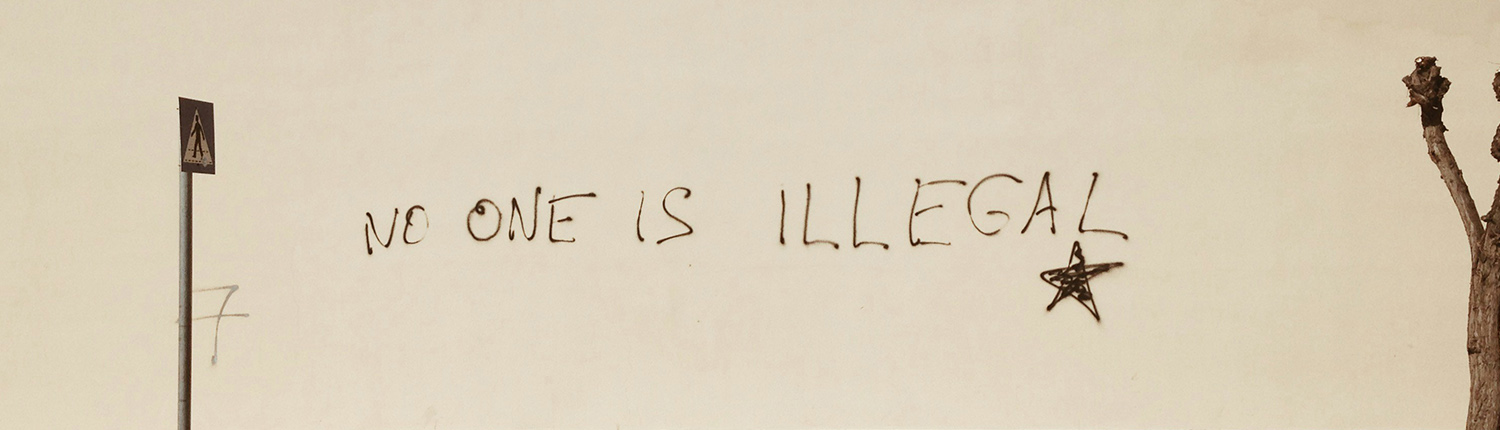Le cisterne obliate
La falde acquifere sono dei contenitori idrici sotterranei e rappresentano una componente fondamentale del ciclo geochimico dell’acqua: quando piove, l’acqua raggiunge il terreno e ha tre possibili destinazioni: fluisce nei ruscelli, fiumi, laghi per poi evaporare nuovamente; viene assorbita dalla vegetazione, parte di essa sarà rilasciata sotto forma di vapore durante il processo traspirazione; oppure penetra il terreno spingendosi attraverso la zona insatura superando la superficie freatica per raggiungere il livello del sottosuolo dove è presente l’acqua – la zona satura.
Le falde sono un elemento del bacino idrogeologico che può essere composto da uno o più acquiferi costituenti le unità idrogeologiche maggiormente permeabili entro cui le acque sotterranee fluiscono. Il bacino idrogeologico è solitamente composto da materiali permeabili differenti come ghiaia e sabbia non compattata, rocce sedimentarie come l’arenaria e il calcare, o ancora rocce vulcaniche e cristalline fratturate.
Grafico 1: Dati sui consumi idrici e capitalizzazione di mercato di cinque grandi società del settore agroalimentare. Sebbene la Nestlè abbia registrato una diminuzione del 15% rispetto al 2020, la sua impronta idrica rimane la più alta tra le aziende del settore. Se il modello consumistico odierno rimarrà invariato si verificherà un deficit idrico del 40% entro il 2030. Si prevede che i governi nazionali imporranno maggiori controlli e normative più rigide come per esempio limiti sui prelievi di acqua fresca, ma la lentezza burocratica, l’avanzamento tecnologico e i conflitti di interessi sono un ostacolo allo sviluppo di un’industria agroalimentare sostenibile (Total Water Withdrawal by Top Food Companies in 2021, Global Data).
La ricarica naturale delle falde è rappresentata dalle precipitazioni, dalle infiltrazioni provenienti da fiumi o laghi e dalle attività agricole quando le colture sono irrigate più del necessario. Al contrario il sovra-sfruttamento delle falde o lunghi periodi di siccità determinano una riduzione delle risorse disponibili. Altri fattori che influenzano la disponibilità di acqua sotterranea sono la velocità di evaporazione; le caratteristiche del suolo; la quantità e il tipo di vegetazione; la porosità e la permeabilità del terreno e delle rocce. Infine, l’acqua sotterranea a sua volta contribuisce al mantenimento del livello e del flusso in fiumi, laghi e zone paludose, specialmente nei periodi di siccità.
Le acque presenti nel sottoterra, infatti, non stanno ferme, ma si muovono molto lentamente spinte dalla gravità finché vengono scaricate in un’altra falda o un altro invaso a meno che non ci siano impatti antropici come le attività di pompaggio dei pozzi. La scarsa velocità e la posizione sotterranea di queste riserve naturali d’acqua implica che l’impatto negativo delle attività umane è difficile da identificare con certezza e può durare a lungo.
Figura 1: Il bacino idrogeologico: le falde sono un elemento del bacino idrogeologico che può essere composto da uno o più acquiferi costituenti le unità idrogeologiche maggiormente permeabili entro cui le acque sotterranee fluiscono. L’acquifero è la sede della falda ma i due termini non sono sinonimi poiché non sempre corrispondono. Nel caso dell’acquifero confinato – delimitato sia superiormente che inferiormente da rocce impermeabili, l’acqua è presente in tutto lo strato roccioso (l’acquifero corrisponde alla falda), mentre l’acquifero più vicino alla superficie non è mai completamente saturo proprio per permettere all’acqua piovana di filtrare nel terreno e di ricaricare la falda.
Le acque sotterranee nel Levante
Le Falde Acquifere della regione del Levante sono costituite da calcare e dolomite e attraversano i confini di Israele, Palestina, Giordania e Siria e quindi la loro gestione è particolarmente problematica. L’impatto antropogenico sulle falde della regione ha due principali conseguenze: l’aumento della salinità dovuto al sovrasfruttamento e all’aumento della superficie marina; e la contaminazione dell’acqua causata dall’assenza di adeguati sistemi di depurazione dei liquami e dei rifiuti industriali.
In questa regione arida e scarsamente interessata dalle precipitazioni, le risorse idriche sotterranee sono rappresentate dalla Falda Acquifera Montana che giace sotto la Cisgiordania e si estende dalla valle del Fiume Giordano a est fino al Mar Mediterraneo a ovest; e la Falda Costiera che si estende lungo la piana costiera della catena montuosa del Carmel a nord sino a Gaza nel sud. Meno consistenti sono le risorse idriche sotterranee della Galilea Occidentale, le Falde Carmel a nord e la Falda Negev-Aravah a sud.
Le acque sotterranee sono la principale risorsa di acqua fresca dei palestinesi, rappresentando il 69% delle risorse idriche. La disponibilità d’acqua in tutta la Palestina è di 417.9 MCM, di cui 289 MCM provengono dai pozzi costruiti dagli arabi che prelevano dalla falda a un ritmo sempre più elevato che corrispondeva al 79% nel 2019, creando un rischio per la disponibilità futura perché il tasso di ricambio è già molto inferiore al tasso di estrazione.
La Falda Acquifera Montana è la maggiore della regione ed è interessata da abbondanti piogge che ricaricano l’acqua sotterranea con una media di 721 MCM. Si divide in tre sottobacini: Occidentale, Orientale e Nord-Orientale che scorrono verso nord e ovest in direzione del territorio di Israele e verso est alimentando il fiume Giordano. Il rendimento sostenibile di queste risorse è di 360 MCM annui, ma solo Israele ne estrae circa 600 MCM, che ammonta a un terzo del consumo di acqua fresca da parte dello stato ebraico.
Per far fronte alle crescenti infiltrazioni saline provenienti dal corpo idrico salato che giace sotto la falda, Israele ha sviluppato moderni impianti di desalinizzazione che hanno garantito il recupero dei livelli ottimali delle falde e oggi l’Autorità delle Acque di Israele sta mantenendo un tasso di estrazione sostenibile, limitando allo stesso tempo l’inquinamento del suolo e dell’acqua derivato da attività antropiche. L’accesso alla risorse della Falda Montana è particolarmente problematico per ragioni geomorfologiche e politiche: a tutt’oggi l’acqua estratta dalla popolazione araba della Cisgiordania non supera il 14% del potenziale complessivo dei tre sottobacini perché il bacino idrico si estende sotto un’area condivisa da Israele e dall’Autorità Palestinese, come stabilito negli Accordi di Oslo.
Le relazioni tra i palestinesi e le loro risorse idriche sono vincolate alle decisioni e provvedimenti dell’Autorità delle Acque di Israele e della società idrica nazionale Mekorot che hanno un accesso all’acqua sotterranea illimitato.
La situazione è molto diversa a Gaza, dove le piogge sono meno abbondanti e la Falda Acquifera Costiera viene ricaricata al massimo per 60 MCM annui. A Gaza i pozzi sono pochi rispetto a quelli in Cisgiordania, ma estraggono molta più acqua – 187.6 MCM nel 2019 – il che indica un allarmante depauperamento delle riserve idriche sotterranee, con il livello dell’acqua della falda che è sceso di 19 metri sotto il livello del mare. Israele non permette ai palestinesi di trasferire l’acqua dalla Cisgiordania a Gaza e quindi la popolazione araba è costretta a estrarre più risorse idriche dove queste scarseggiano mentre sono privati dello sfruttamento dell’acqua dove questa abbonda.
All’eccessivo prelevamento dell’acqua di falda e al conseguente aumento del livello di salinità, si affianca l’inquinamento dovuto ad attività antropiche, come le infiltrazioni di agenti chimici usati in agricoltura – fertilizzanti e pesticidi, la contaminazione da rifiuti industriali e il rilascio dei liquami nei corsi d’acqua superficiali che si infiltrano nella falda. Di conseguenza, lo stato del bacino idrogeologico sotto Gaza è in condizioni tragiche con circa il 96% dell’acqua di falda imbevibile. In contrasto, secondo il Servizio Idrologico di Israele, solamente il 15% dell’acqua pompata nella parte settentrionale della Falda Costiera non soddisfa i requisiti di potabilità per l’elevata concentrazione di cloro e nitrati e circa il 40% dei pozzi israeliani installati nel 1980 non è più in uso. Per far fronte a questo problema, a partire dagli anni 2000 Israele ha fatto ingenti investimenti in impianti di depurazione e oggi la Falda Costiera contribuisce con un quantitativo d’acqua pari a 240-300 MCM al fabbisogno idrico della popolazione dello stato ebraico.
Riscaldamento climatico e crisi idrica nel Levante
Le falde acquifere rappresentano già una fonte idrica fondamentale per la regione del Levante, ma la loro importanza sarà ancora più significativa nel prossimo futuro perché il tasso di evaporazione delle acque superficiali è in continuo aumento con differenze sensibili in base all’area: nel 2019 a Jerico e a Hebron si sono registrati incrementi del 15% e del 29% rispettivamente sopra la media annuale. Si stima infatti che la regione sarà interessata da un generale incremento delle temperature medie stagionali entro il 2100 che si affiancherà all’allungamento della stagione calda e secca da quattro a sei mesi mentre l’inverno si accorcerà da quattro a due mesi.
Inoltre, le precipitazioni stagionali diminuiranno fino al 40% in alcune aree, ma saranno molte più intense in altre in periodi annuali circoscritti. Questa dinamica ridurrà drasticamente la copertura vegetativa del suolo, elemento fondamentale per la prevenzione della siccità e dell’erosione. Il repentino riversamento delle piogge in periodi brevi e limitati e in assenza di vegetazione avrà risvolti ancor più drammatici, come l’incremento della frequenza delle alluvioni e la diffusione di malattie tropicali come il colera.
Una ricerca della NASA stima che tale periodo di siccità acuta e prolungata potrebbe essere già alle porte: la secca iniziata nel 1998 nel Mediterraneo Orientale sarebbe la più acuta degli ultimi nove secoli e contribuirà all’aumento della desertificazione e degli incendi boschivi. La regione ha già avuto delle ondate di calore molto acute negli ultimi anni che hanno impattato negativamente i raccolti, il bestiame e le persone. Infine, l’innalzamento della superficie marina, oltre a incrementare l’intrusione di acqua salata nelle falde acquifere costiere, potrebbe anche minacciare la terra, il suolo e le infrastrutture costiere, mentre il riscaldamento dell’oceano potrebbe impattare negativamente sulle attività ittiche tanto Palestinesi quanto Israeliane. Come sottolineato da Karry B. Anderson, consulente del rischio politico in Medio Oriente, “i cambiamenti climatici avranno molti effetti su Israele e i Territori Occupati, ma il più importante sarà la diminuzione della fornitura d’acqua.”
Scarsità strutturale
Si è già discusso di come i compromessi politici legati alla gestione delle risorse idriche possono garantire l’ammodernamento delle infrastrutture idriche e quindi compensare la scarsità stagionale o al contrario determinare il deterioramento delle infrastrutture con la conseguente diminuzione della disponibilità di acqua potabile per i cittadini e di acqua utilizzabile per le attività agricole e i processi industriali. Le decisioni politiche possono assumere una rilevanza ancora maggiore quando due Paesi condividono le proprie risorse idriche come nel caso di Palestina e Israele, dove i conflitti per l’acqua possono essere fatti risalire al periodo del Mandato Britannico (1923 – 1948), quando il governo Inglese affidò all’idrologo Michael Ionides l’analisi delle risorse idriche e il potenziale di irrigazione del Bacino della Valle del Giordano. La gestione indipendente delle risorse perdurò fino al 1967, quando Israele iniziò l’occupazione illegale della Palestina. La presenza dei coloni non comporta solamente l’usurpazione degli spazi ma anche (e soprattutto) delle risorse “nascoste” come le falde sotterranee che vennero dichiarate proprietà dello stato dopo la fine della guerra. Inoltre, la valle del fiume Giordano, storicamente una zona abitata dai nomadi arabi, è divenuta un’area militare limitata all’accesso dei Palestinesi. Subito dopo la guerra, nel novembre 1967, l’autorità israeliana emanò l’Ordine Militare 158 imponendo rigide restrizioni sull’approvvigionamento dei palestinesi che non possono costruire nuovi impianti idrici senza aver prima ottenuto un permesso dall’esercito di Israele. Poco o nulla servirono gli Accordi di Oslo che prevedevano il principio di “utilizzo equo” della risorsa idrica e tutt’oggi ai palestinesi viene ancora negata la possibilità di trivellare pozzi, installare pompe sommerse o sviluppare pozzi esistenti senza prima aver ottenuto un’autorizzazione che è praticamente impossibile da ricevere. Tra il 1967 e il 1989, in Cisgiordania sono stati costruiti 36 pozzi dai coloni ma nemmeno uno dai palestinesi. Inoltre, i coloni supportati dall’esercito israeliano distruggono sistematicamente le cisterne in cui le comunità palestinesi tradizionalmente stoccavano l’acqua piovana.
Un’altra questione che ben esemplifica le privazioni strutturali imposte sui consumi idrici dei palestinesi è rappresentata dagli impianti di desalinizzazione e depurazione delle acque reflue. A Gaza, le tecnologie di desalinizzazione comprendono 150 impianti di piccole dimensioni di cui oltre la metà è di proprietà privata e utilizzano il processo dell’osmosi inversa senza però monitorare la qualità dell’acqua. In Cisgiordania gli impianti sono pochi e di capacità limitata con 162 pozzi che impiegano le acque salmastre per l’irrigazione. Il governo di Tel Aviv, invece, dispone di cinque moderni impianti per la desalinizzazione dell’acqua marina situati sulla costa che da soli producono artificialmente più del 50% dell’acqua potabile consumata dallo stato ebraico. Questi impianti sono direttamente connessi al National Water Carrier (NWC), un sistema che trasporta l’acqua da nord alle regioni aride del sud che hanno sensibilmente aumentato il consumo idrico sulle spalle delle regioni settentrionali, che invece si sono impoverite. Gli impianti di desalinizzazione, tuttavia, hanno un peso economico ed ecologico perché necessitano di molta energia e quindi aumentano la presenza di Co2 nell’atmosfera; funzionano grazie all’uso di componenti chimici dannosi e richiedono la confisca di aree costiere con impatti negativi sull’ecosistema marino. Inoltre, questi impianti producono acqua priva di iodio che ha seri impatti sulla salute pubblica. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue, il 53% dei palestinesi è connesso a sistemi di depurazione, la restante parte viene scaricata direttamente nell’ambiente. A Gaza la rete fognaria ammonta a 1888 km, tuttavia spesso i costi energetici per operare tale infrastruttura impattano negativamente il servizio di depurazione. Solo nel 2004, 60 milioni di metri cubi di liquami sono stati scaricati nell’ambiente dai palestinesi inquinando i corsi d’acqua della Cisgiordania che scorrono verso Israele, contaminando così le falde acquifere sotterranee di tutta la regione. La situazione è ancor più drammatica nelle zone industriali come Hebron, dove vengono scaricati nell’ambiente sostanze cancerogene che inquinano l’acqua usata dagli impianti di desalinizzazione di Israele. A confronto, Israele ha installato sin dagli anni ’80 diversi impianti di depurazione, arrivando ad averne 87 di grandi dimensioni che in totale trattano 1000 m3 al giorno. Come evidenziato da una ricerca dell’Università di Cincinnati (2014), l’impossibilità dei palestinesi di dotarsi di moderni ed efficienti impianti di depurazione è una diretta conseguenza dell’occupazione: Israele continua a negare alla Palestina progetti di sviluppo per la gestione dei liquami e impedisce la costruzione di infrastrutture idriche, anche quelle finanziate da attori esterni. L’unico impianto realizzato nel 1998, finanziato dall’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale dell’ONU, è tuttora inutilizzato perché Israele teme che una delle componenti di riciclo – l’acido solforico – possa essere utilizzata dai palestinesi per costruire ordigni esplosivi.
Come risultato di tutte queste privazioni strutturali, a fronte dei 300 litri giornalieri consumati da un israeliano medio, un palestinese in media dispone tra i 60 e i 90 litri d’acqua al giorno, tra le comunità nomadi questo numero può scendere a 20 litri, ben al di sotto del limite minimo stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di 100 litri al giorno, e oltre 180 comunità palestinesi delle aree rurali della Cisgiordania sono senza acqua corrente (OCHA).
Apartheid idrico
L’occupazione della terra della Cisgiordania da parte degli oltre 600 mila coloni israeliani è basata sulla sistematica depredazione e separazione dei palestinesi dalle loro risorse naturali, specialmente quelle idriche. Il diritto d’accesso all’acqua è un diritto umano fondamentale tutelato dalla Quarta Convenzione di Ginevra che si interseca con altri diritti fondamentali che lo Stato occupante deve garantire allo Stato occupato – come il diritto al cibo, alle forniture mediche e alla salute pubblica.
Tuttavia, dopo il 1967, i coloni ebrei diedero inizio a un processo di isolamento e rimozione delle risorse idriche realizzato con la coercizione, la violenza e l’imposizione di un regime di scarsità che caratterizza la vita di tante comunità della Cisgiordania. Questo processo può essere ricostruito come segue: dopo la guerra dei Sei Giorni, i primi coloni iniziarono da subito a creare degli avamposti in Cisgiordania che vennero prontamente collegati alla rete idrica al fine di ottenere un sistema di distribuzione a gestione totalmente israeliana e destinato all’uso esclusivo della popolazione ebrea; successivamenti gli avamposti si allargarono e diventarono gli odierni insediamenti – i kibbutz – e oggi se ne creano sempre di nuovi e con maggiore aggressività; allo sviluppo dei kibbutz, si affianca l’attività dei coloni che armati e sostenuti dall’esercito incendiano le case, bloccano il traffico, manomettono le reti elettriche, tagliano i tubi per l’irrigazione e confiscano i campi.
Grafico 2: Totale delle risorse idriche palestinesi. L’acqua di falda è un risorsa fondamentale perché i palestinesi della Cisgiordania non hanno accesso alle acque superficiali mentre a Gaza sono privati delle possibilità di costruire moderni impianti per la desalinizzazzione dell’acqua. Il continuo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee unitamente all’apartheid idrico imposto dallo stato ebraico stanno causando l’eccessivo sfruttamento della falda che viene contaminata dal bacino idrico salino che si trova sotto di essa e dalle attività antropiche come lo smaltimento dei liquami e l’eccessivo uso di fertilizzanti. Il grafico mostra la conseguenza del regime di scarsità strutturale imposto da parte di Israele: i palestinesi segregati dalle loro risorse idriche e sono costretti ad acquistare sempre più acqua a prezzi molto svantaggiosi dalla società nazionale israeliana Mekorot con impatti negativi per la salute umana e per il sostentamento delle attività agricole che costituiscono la base dell’economia palestinese.
La privazione della risorsa idrica ha costituito e costituisce un elemento fondamentale del colonialismo di Israele che ha potuto creare dei corridoi invisibili che trasportano acqua in tutte le regioni dello stato ebraico e tendono a compattare la presenza dei coloni e a isolare la sempre più rarefatta presenza palestinese. Similmente, la valle del Giordano è divenuta una zona militare dove Israele sta realizzando un progetto per incanalare l’acqua da Gerusalemme Est e trasportarla nella vallata per alimentare le piantagioni di datteri dei coloni, limitando l’accesso alle risorse idriche dei 65mila palestinesi della regione.
In tutta l’Area C – zona amministrativa israeliana – Israele disconosce il diritto all’acqua dei palestinesi che vivono in questa regione da molte generazioni e ironicamente sono costretti a recarsi due volte al giorno al punto di ricarica idrica più vicino gestito dalla società Mekorot quando l’azienda stessa è proprietaria delle tubazioni che scorrono sotto le loro case. La società nazionale Mekorot fornisce l’acqua ai servizi idrici palestinesi, ma spesso impone arbitrarie restrizioni alla distribuzione come nell’estate del 2023, quando l’Autorità Idrica Palestinese (PWA) ha segnalato una riduzione della fornitura giornaliera nelle città di Hebron e Betlemme senza apparenti motivazioni o ragioni tecniche.
La decisione di ridurre l’equivalente di 6000 bicchieri giornalieri è stata definita dalla PWA una mossa “razzista” soprattutto durante il torrido periodo estivo. A causa di queste restrizioni, le comunità palestinesi della Cisgiordania non hanno altra scelta che acquistare l’acqua trasportata da camion sempre di proprietà della Mekorot a un prezzo molto maggiore che varia tra i 4 e i 10 dollari per metro cubo. Per le comunità più povere, le spese per l’acquisto dell’acqua possono arrivare a occupare la metà delle entrate mensili di tutta la famiglia. La Mekorot è responsabile della sistematica apertura di pozzi e della captazione delle sorgenti della Cisgiordania per rifornire la popolazione israeliana, inclusi i coloni che vivono negli insediamente illegali.
Nel 1972, la Mekorot stabilì un’importante stazione di pompaggio captando la sorgenti di Wadi Auja che rappresentava una fonte d’acqua abbondante e riforniva i villaggi e i campi arabi attraverso una serie di canali di irrigazione. Le pratiche coercitive della Mekorot paiono simmetriche a quelle dei coloni che sin dagli anni ’70 hanno fondato nuovi insediamenti inglobando le sorgenti locali e costringendo la popolazione araba a comprare l’acqua dalla società israeliana.
Un esempio è il villaggio di Qaryut, dove le cinque sorgenti locali sono state sistematicamente captate dai coloni sin dagli anni ’80. La segregazione dei palestinesi dalla loro terra avviene in reiterate azioni di violenza quotidiana come quella del 27 marzo 2022 quando sette coloni e cinque soldati hanno allontanato dai loro campi alcuni contadini arabi, due dei quali hanno filmato i coloni rubare quattro bobine di tubi da irrigazione in plastica che sarebbero serviti per l’installazione di un sistema di irrigazione a goccia interamente finanziato dalla Croce Rossa.
Dopo la ripresa dal conflitto armato il 7 ottobre 2023, l’aggressività dei coloni è divenuta sempre maggiore. A fine anno, dopo aver distrutto uno dei grandi bacini d’acqua vicino a una delle sorgenti di Qaryut che era impiegato da generazioni di contadini palestinesi per l’irrigazione, i coloni e l’esercito hanno chiuso l’accesso alla fonte e si sono messi al lavoro per trasformare il bacino in una grande piscina.
Le conseguenze dell’apartheid idrico hanno effetti ancora maggiori per le attività agricole, base dell’economia palestinese. I tradizionali coltivatori di agrumi hanno dovuto diversificare i loro raccolti a causa della scarsità di acqua e possono piantare solamente sementi che non richiedono molta acqua e che allo stesso tempo sono meno redditizie, come zucchine, zucche e cetrioli. In passato, i coltivatori arabi di agrumeti erano anche attivi esportatori di limoni e arance che costituivano una entrata economica fondamentale.
Amnesty riporta il caso di un contadino ed ex-esportatore nel villaggio Al-Auja che nel 2017 ha avuto accesso all’acqua per soli 40 giorni perdendo il raccolto di zucche che ne richiede almeno 120 all’anno. Inoltre, molti dei residenti di questo villaggio sono stati costretti a trovare lavoro nelle fattorie situate negli insediamenti dei coloni, il cui accesso all’acqua è illimitato. Simil sorte è toccata al villaggio di Furush Beit Dajan nel nord della Cisgiordania con una popolazione di 930 persone, noto per la coltivazione degli agrumi. In concomitanza dei tanto attesi Accordi di Oslo nel 1995, i contadini del villaggio hanno dovuto diversificare il loro raccolto per mancanza d’acqua perché i confinanti insediamenti israeliani di Hamra e Mehora hanno esaurito le riserve idriche della Falda Orientale che avevano iniziato a sfruttare dagli anni ’70.
Conclusioni
Le falde acquifere rivelano il paradigma del modello consumistico moderno: risorse nascoste di cui ignoriamo l’esistenza e l’importanza continuano a essere prelevate a un ritmo sempre maggiore e vengono contaminate dalle sempre più invadenti attività antropiche. Nel Levante, il mantenimento del buono stato delle acque sotterranee rappresenta una sfida ancor più complessa perché la loro gestione è condivisa da Israele e dalla Palestina, perennemente in guerra sin dagli anni ‘20 del secolo scorso.
Il tasso di estrazione di queste risorse è già molto elevato ed è destinato ad aumentare a causa dei cupi prospetti dei cambiamenti climatici che diminuiranno la presenza delle acque di superficie. A questo si aggiunga che Israele impone un regime di scarsità strutturale attraverso leggi ad-hoc e arbitrarie restrizioni sullo sfruttamento delle risorse della terra dei palestinesi a cui si affianca la complicità tra l’azienda Mekorot che controlla le risorse idriche della regione e la violenza dei coloni della Cisgiordania che anela al completo isolamento dei palestinesi dalla loro risorse e quindi dalla loro terra.
Questa situazione drammatica lede entrambe le parti e non avrà vincitori né vinti: le acque della Falda Montana sono le risorse principali della regione e scorrono dalla Cisgiordania verso il territorio settentrionale israeliano. Si capisce che se queste saranno irreversibilmente contaminate entrambi gli stati dovranno perseguire lo sviluppo di nuove tecnologie e trovare un accordo per preservare le risorse idriche della regione che non seguono i confini decisi dalla politica nazionale degli stati sovrani.
Bibliografia
- Anderson K. B., Climate Change Highlights Israeli-Palestinian Inequities, Arab News, 01 ottobre 2019: https://www.arabnews.com/node/1562541
- Amnesty International (2009). Troubled Waters – Palestinians Denied Fair Access to Water. Amnesty International Publications.
- Amnesty International (2017). The Occupation of Water. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/the-occupation-of-water/
- Baumgarten P.A. (2009). Israel’s Transboundary Water Disputes. Pace University School of Law.
- Eyad Y. Yaqob et als, Situation Analysis and Perspectives of Transboundary Wastewater Management Along Israel/palestine borders, Asian Journal of Applied Science and Engineering volume 3, University of Cincinnati, 2014.
- Global Data (2022). Total Water Withdrawal by Top Food Companies in 2021.
- Israel-Palestine: Water Sharing Conflict. Climate Diplomacy https://climate-diplomacy.org/case-studies/israel-palestine-water-sharing-conflict.
- Khan B., (2021). Palestine is suffering an ecological apartheid. Gizmodo. https://gizmodo.com/palestine-is-suffering-an-ecological-apartheid-1846944042
- La paperson (2017). A Third University is Possible. University of Minnesota Press.
- Liboiron, M. (2021). Pollution is Colonialism. Duke University Press.
- Najib M. (2021). Palestine runs dry: “Our water they steal and sell to us.” Aljazeera.
- Scocchera E.,Minutolo A. Acque Sotterranee. Il necessario è invisibile aglio occhi. Ufficio Scientifico Legambiente.
- Paris G.S. (2024). La Forma dell’Acqua nell’Era Industriale. Atmospheralab. https://www.atmospheralab.com/scienza-e-ambiente/la-forma-dellacqua-nellera-industriale.html
- Shahadeh, A Rift in Time: Travel with my Ottoman Uncle, OR Books, 24 febbraio 2011.
- Tal N., Mahajna A. (2023) Israel Water Report. Fanack Water.
- The New Arab Staff (2023). Israeli Water Company Mekorot reduces water supply to West Bank’s Bethlehem and Hebron. The New Arab. https://www.newarab.com/news/israeli-company-reduces-water-supply-palestinians
- Tuck, E., Yang, K. W. (2012). Decolonization is not a metaphor. Decolonization: Indigeneity, Education & Society Vol. 1, No. 1, 2012, pp. 1-40.
- Varanasi, How Colonialism Spawned and Continued to Exacerbate the Climate Crisis, Columbia Climate School, 21 settembre 2022: https://news.climate.columbia.edu/2022/09/21/how-colonialism-spawned-and-continues-to-exacerbate-the-climate-crisis/.
- United Nation, Acquisition of Land in Palestine, New York 1980 https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-208638/
- Wawi A. (2023) Palestine Water Report. Fanack Water.
- What is Groundwater? Igrac https://www.un-igrac.org/what-groundwater

Laureato in Chinese Studies (Unibg e Unimc), si sta laureando in Environmental Humanities all’Università Ca’ Foscari. È insegnante di italiano in una scuola privata di Pechino. Crede nell’importanza della giustizia ambientale.