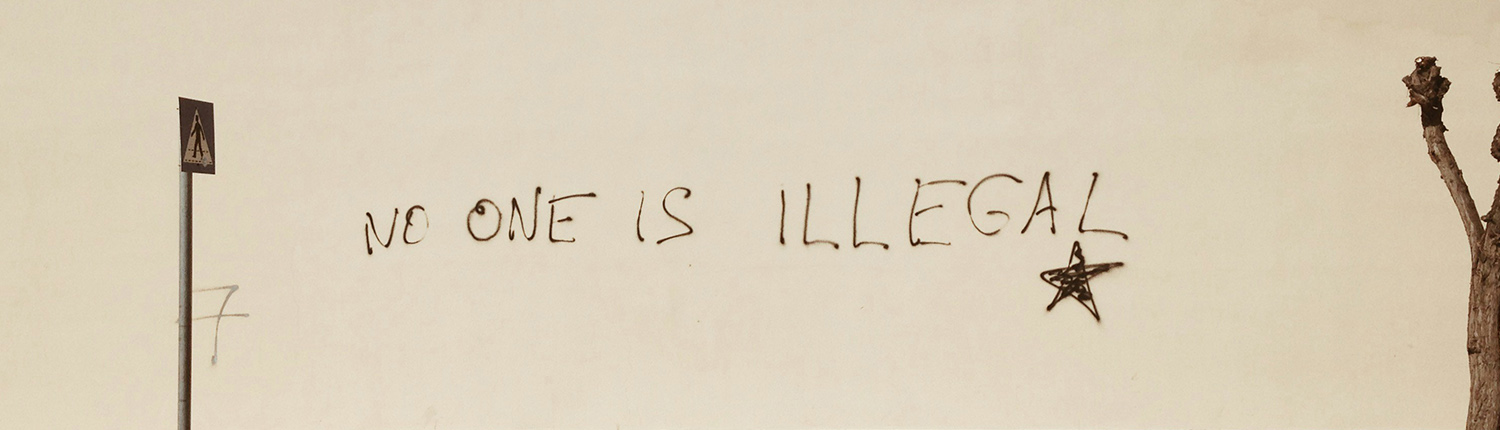L’origine delle differenze: l’agricoltura
Date queste premesse, è lecito chiedersi quando, dove e perché alcuni uomini hanno avuto la possibilità e il bisogno di produrre nuove tecnologie in misura molto maggiore rispetto ad altri.
Diamond, nel suo libro, pone la nascita dell’agricoltura come spartiacque nella storia delle innovazioni, circa 10 mila anni fa. L’agricoltura è nata indipendentemente in varie parti del mondo, ma a cambiare le sorti dell’umanità sono state le prime popolazioni che si stanziarono nella Mezzaluna Fertile, situata a cavallo fra la Turchia e la Siria. Lì – e solo lì – c’erano cereali e animali facilmente addomesticabili che potevano assicurare una quantità sostanziosa e variegata di nutrienti a lungo termine.
La coltivazione, però, ha portato con sé una serie di problemi: per rendere l’agricoltura vantaggiosa servivano tecniche di raccolta, di stoccaggio, di semina e in grado di trasformare gli alimenti rendendoli maggiormente commestibili e appetibili.
Col passare del tempo, tutte le innovazioni inventate per risolvere queste difficoltà hanno determinato una separazione sempre più marcata fra le tribù nomadi di cacciatori–raccoglitori e le tribù stanziali dedite alla coltivazione e alla domesticazione di animali.
L’innovazione nasce dalla necessità: la rincorsa alle risorse
Grazie all’agricoltura, in pochi millenni attorno al Mar Mediterraneo sorsero le prime civiltà urbane: dagli Assiri fino ai Romani. Molte di queste erano strutturate in Imperi, forme di governo in cui una sola autorità ha la supremazia sui sottoposti.
Questo tipo di organizzazione veniva preferito quando occasionalmente, per varie ragioni, un popolo poteva godere di un aumento demografico. Oggi come allora, l’aumento della popolazione comporta una maggiore richiesta di risorse, che può raggiungere una dimensione tale da non potersi più sostentare con i beni locali. Di fronte a questo problema, la soluzione è stata quella di acquisire le risorse dai territori vicini. Dato che il commercio implica un costo nello scambio, ottenere ciò di cui si ha bisogno con la forza consente di sfruttare l’unica risorsa in surplus: le persone. Di conseguenza, per queste civiltà l’investimento nella tecnologia bellica è risultato per millenni il più efficace e vantaggioso da realizzare.
Nel frattempo che andavano formandosi gli imperi, le popolazioni situate nelle regioni centrali dell’Africa rimasero strutturate in piccole tribù semi-nomadi. Questa forma di organizzazione è basata sulla ricerca di piante spontanee e la caccia di selvaggina, per cui la quantità di risorse è fortemente limitata. Un aumento occasionale della popolazione innesca una serie di conseguenze che ristabiliscono il numero di individui su un “valore di equilibrio” imposto dall’ecosistema.
Per le tribù semi nomadi è risultato quindi più vantaggioso trovare delle pratiche che mantenessero il numero di individui della tribù quanto più vicino a quello di equilibrio. Una necessità profondamente diversa da quella delle civiltà urbane, che ha condotto le popolazioni africane a non dover investire nello sviluppo di tecnologie atte a sostentare (o uccidere) una gran quantità di individui.
Le conseguenze del colonialismo: dall’età delle scoperte alla crisi climatica
La predazione del continente africano è iniziata in modo sistematico nella seconda metà del Quattrocento, con l’avvento delle esplorazioni della costa occidentale e della regione sub-sahariana dell’Africa. Dopo secoli di sfruttamento diretto e schiavitù, il costo del secondo conflitto mondiale rese insostenibile il mantenimento delle colonie in quanto tali: le popolazioni locali colsero così l’occasione per ottenere l’indipendenza, spesso però solo formale e non effettiva.
È doveroso constatare che ancora oggi i neonati Stati africani si trovano subordinati agli interessi degli altri paesi, rimanendone così dipendenti. In aggiunta a tutto ciò, si trovano a dover pagare il prezzo maggiore della crisi climatica. Ci sono però delle realtà che cercano di portare avanti il percorso di identità e indipendenza dell’Africa, partendo proprio dal ripristino delle risorse naturali tramite progetti di riforestazione, come “Billion Trees Project”.
In conclusione, fortunatamente oggi si è in grado di rispondere alla domanda posta dall’immaginario studioso extraterrestre senza dover ricorrere ai giudizi di valore che hanno alimentato il pensiero razzista fin dall’antichità. Grazie all’antropologia, si possono scoprire le necessità che hanno portato il genere Homo a servirsi della tecnica. Grazie alla storia, si può capire come si è arrivati alla situazione attuale e suggerire pratiche per risolverla: lo sfruttamento di materie prime deve subire un freno ed è necessario ripensare alla nostra concezione del mondo naturale.

Laureato in Biologia Molecolare e in Biologia Evoluzionistica (UniPd), è appassionato di saggistica scientifica.
Si propone ad Atmosphera Lab con l’intento di mettersi alla prova e scrivere di ciò che da sempre muove la sua curiosità: l’ambiente.