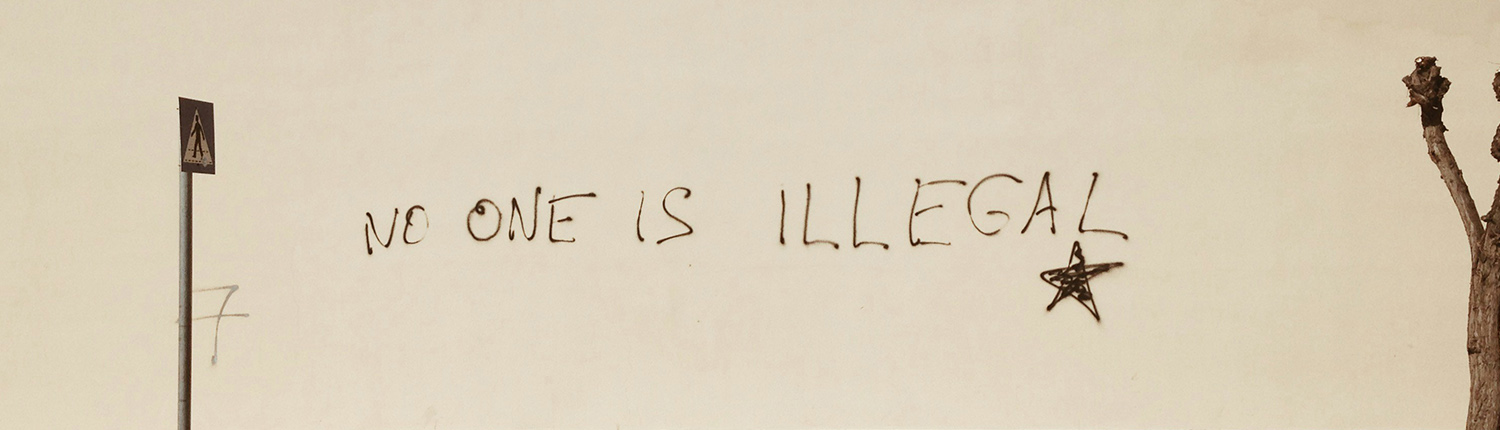Figura 1. Andamento del consumo di suolo annuale netto a livello regionale dal 2006 al 2021. Fonte: elaborazione ISPRA su cartografia SNPA.
L’invadente «partito del cemento» (pag. 13) in Italia – e non solo – non conosce né regione né orientamento politico, e si muove trasversalmente su tutta la penisola da decenni: sembra dunque che ad accomunare le regioni italiane sia l’(ab)uso di suolo (fig. 1). Come sottolineato da Settis, i dati relativi al consumo di suolo sono complessi e, nonostante i report, le tabelle e i diagrammi, non sempre è facile riuscire ad avere un’idea adeguata sulla situazione e di come questa si sia evoluta nel tempo. Ciò crea difficoltà per chi cerca di orientarsi fra le informazioni – provocando una riduzione dell’interesse sulla questione.
Nel 2021, secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la regione con il maggiore consumo di suolo è stata la Lombardia con 12,12% del territorio, e quella con il minore consumo la Valle d’Aosta con 2,15% (fig. 2).
Inoltre, dal rapporto relativo al 2022 su Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), si può notare come la Pianura Padana e i pressi di Napoli siano le zone in cui, dal 2006 al 2021, si ha avuto un maggiore consumo di suolo (fig. 3).
Settis pone alcune riflessioni che possono aiutarci a valutare la situazione italiana in modo profondo: come mai quello che era il “giardino d’Europa” si sta rovinando in questo modo? Ciò che avviene è una involuzione culturale passeggera o una profonda mutazione?
Figura 2. Confronto fra la percentuale per regione di suolo consumato (2021) e la media nazionale. Fonte: elaborazione ISPRA su cartografia SNPA.
Figura 3. Localizzazione dei principali cambiamenti dovuti al consumo di suolo fra il 2006 e il 2021. Fonte: elaborazione ISPRA su cartografia SNPA.
Il suolo
Il termine “suolo” indica l’insieme delle componenti gassose (aria e gas racchiusi all’interno), liquide (acqua o altri liquidi) e solide (organiche e inorganiche) che troviamo nella parte più esterna della crosta terrestre. La sua formazione, chiamata pedogenesi, può richiedere tempi variabili, ma le stime dicono che 1 cm di suolo (fertile) impiega dai cento ai mille anni per formarsi.
Il suolo ha varie funzioni: è la casa della biomassa vegetale (base di ogni catena alimentare), è una riserva di biodiversità, garantisce la qualità delle acque superficiali e profonde, regola la CO2 nell’atmosfera (è il secondo serbatoio di carbonio dopo gli oceani) e stabilizza il terreno nel caso di frane, alluvioni e piogge intense. L’alterazione del suolo, seppur esigua, da parte delle azioni umane mette in pericolo queste e altre delle sue funzioni ecologiche.
L’Agenzia Europea dell’Ambiente (European Environment Agency, EEA) sottolinea come non sia più possibile ignorare lo stato del suolo per far fronte ai cambiamenti climatici: desertificazione, erosione, dissesto idrogeologico, minore umidità del suolo, diminuzione delle paludi, diminuzione delle zone verdi in città sono tutti fattori che vanno ad influenzare la salute del suolo e che rendono più complesso svolgere azioni di miglioramento del territorio per far fronte agli effetti della crisi ambientale che stiamo vivendo.
Il dissesto idrogeologico: i rischi e le possibili soluzioni un problema anche in Italia
Al netto di quanto detto, la salvaguardia dello stato del suolo e il suo monitoraggio diventano azioni necessarie. A causa della sua storia e della sua morfologia, l’Italia è un paese caratterizzato da un elevato rischio di di dissesto idrogeologico, ovvero il fenomeno per cui il suolo si degrada e diventa instabile a causa di azioni antropiche e non: sempre secondo l’ISPRA, circa il 94% dei comuni italiani è a rischio e il 18,4% del territorio nazionale si trova in aree con la maggiore pericolosità per frane e alluvioni.
Per questo motivo, le iniziative e le tecnologie che permettono di avere migliore sensibilizzazione, gestione e monitoraggio delle aree di rischio diventano una preziosa risorsa (ne avevamo parlato anche nell’articolo riguardo al movimento Billion Trees Projects).
Il progetto RESMYLE, che coinvolge progetti in Francia, Giordania, Italia, Libano e Tunisia, mira a migliorare le condizioni di 25 comunità nella zona mediterranea. Una di queste si trova in Liguria, e attraverso il workshop S.T.R.O.N.G. del 2021 alcuni giovani partecipanti sono stati sensibilizzati al problema dell’instabilità idrogeologica e hanno appreso tecniche per contrastarla.
Bio Soil Expert invece è una startup nata in Trentino Alto-Adige che punta alla ricerca di sistemi innovativi e sostenibili per l’ingegneria naturalistica e idraulica, l’ambiente e l’agricoltura sostenibile. Fra le varie biotecnologie applicate all’ambiente, la start up ha sviluppato un sistema di controllo dell’erosione attraverso l’utilizzo di piante erbacee perenni (chiamate Chiodi Vegetali®, fig. 4) in grado di sviluppare apparati radicali folti e profondi in associazione con i microrganismi già presenti nel suolo. Questo permette alle radici di creare una sorta di “scheletro” che rende il terreno più stabile e ne riduce quindi il rischio di erosione. Allo stesso tempo, le piante riescono anche ad assorbire la CO2 (circa 3 kg per pianta) e ridurre così l’anidride carbonica presente in atmosfera. Presentata all’EXPO di Milano nel 2015, questa tecnologia che prevede l’utilizzo di piante erbacee anziché di additivi chimici o di impianti ingegneristici diventa dunque un esempio di tecnica ecocompatibile con il territorio in cui viene utilizzata, creando un “cemento verde” che non solo stabilizza il terreno ma funge anche da fonte di verde per le aree circostanti.
Figura 4. Fonte: Bio Soil Expert
Capire il passato per migliorare il futuro
Anche Italia c’è la necessità di riflettere, educare e agire sulle condizioni del suolo e su come queste influenzino la vita delle città, in particolare a causa della morfologia della penisola – che comprende i rischi di terremoti, eruzioni, dissesto idrogeologico, erosione delle spiagge e molto altro.
Le innovazioni – come quelle proposte da Bio Soil Expert – permettono infatti di limitare i danni e migliorare le condizioni del territorio, ma rimangono insufficienti se non accompagnate da un cambiamento anche alla fonte, ovvero da un cambiamento delle politiche e delle azioni delle singole persone.
Il libro di Salvatore Settis, in cui il protagonista è il paesaggio, diventa così un romanzo per comprendere come si è evoluta la tormentata relazione fra Italia e ambiente, caratterizzata da una storia di politiche non lungimiranti, abuso edilizio, glorie passate e mancanza di cura generale del territorio. Come l’Italia sia arrivata alla condizione in cui è adesso è un punto cruciale per attuare politiche adeguate, sensibilizzare la popolazione e sviluppare tecnologie in grado di mitigare gli errori passati. Ma come si evince dal libro, la relazione fra popolazione e territorio ha una forte componente culturale che va tenuta in considerazione per una maggiore sostenibilità e per evitare di dimenticare che, dopotutto, il territorio siamo anche noi.

Laureata in Environmental Humanities (Unive) e in Scienze Naturali (Unipd). Appassionata di etologia, lavora come educatrice ambientale ed entra a far parte di Atmosphera Lab come parte del gruppo Social e come articolista nel 2022.