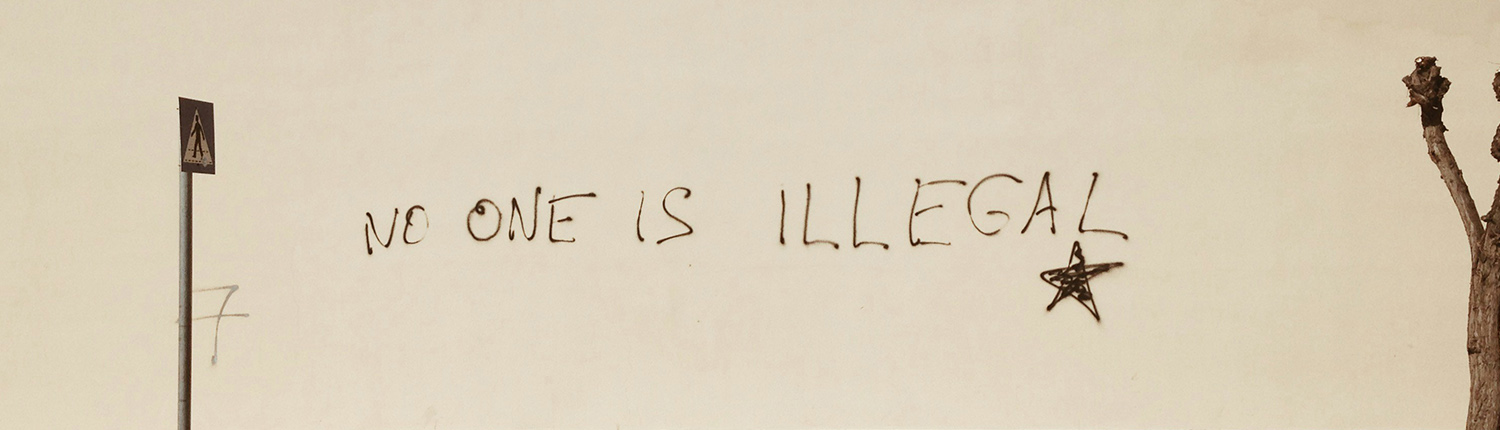La “gentrificazione dell’usato”
Le soluzioni potrebbero essere diverse, la prima delle quali diminuire la produzione e comprare più usato. Questo permetterebbe di frenare lo sfruttamento delle materie prime e attutire le conseguenze dannose dovute alla produzione di una quantità così elevata di capi. Inoltre, comprando second hand si avrebbe un recupero dello scarto che, invece di finire in discarica o disperso nell’ambiente, verrebbe rimesso in circolo per un periodo più ampio, cosa che aiuterebbe a “rientrare nei costi” ambientali dati dalla sua produzione.
Questa modalità potrebbe, però, sollevare delle problematiche per quanto concerne il concetto di sostenibilità sociale: come ha precisato l’influencer Giorgia Pagliuca (@ggalaska) sulle sue piattaforme social, in certi casi si crea una “gentrificazione dell’usato”, per cui il comprare indumenti di seconda mano diventa una moda. Gentrification è infatti un termine che viene usato nell’ambito della sociologia urbana e indica «la riqualificazione e il mutamento fisico e della composizione sociale di aree urbane marginali, con conseguenze spesso non egualitarie sul piano socio-economico». Il suo utilizzo in questo caso, quindi, andrebbe ad evidenziare il fatto che una pratica come comprare vestiti di seconda mano, in origine esercitata soprattutto dai ceti meno abbienti, viene fatta propria da persone con maggiore disponibilità economica. Questo, oltre ad essere semplicemente un altro risvolto del consumismo, toglierebbe la possibilità a chi ha meno solvibilità economica di trovare capi e taglie.
L’economia circolare
Sarebbe dunque necessario cercare soluzioni differenti. Una di queste è la produzione di vestiti attraverso fibre rigenerate. Il concetto alla base è quello dell’economia circolare: lo scarto viene rimesso in circolazione, ritornando a essere materia prima.
Diverse aziende, tra cui, ad esempio, Rifò Lab e Save the Duck, si sono mosse per soddisfare la nuova domanda di moda sostenibile e circolare. Hanno quindi acquisito importanza nell’ambito tessile varie certificazioni, tra cui, per quanto concerne questo articolo, il Global Recycled Standard (GRS) e il Recycled Claim Standard (RCS).
Queste certificazioni, promosse da Textile Exchange, un’organizzazione globale no-profit che si occupa di sostenibilità ambientale e sociale nel settore tessile, garantiscono al consumatore una percentuale di almeno 20 per cento (GRS) o 5 per cento (RCS) di materiali riciclati, che possono provenire sia da scarti post-consumer – indumenti già utilizzati dal consumatore – sia da scarti pre-consumer, ovvero industriali.
Le certificazioni seguono l’intera filiera, promuovendo un minore utilizzo delle risorse vergini e dei prodotti chimici, insieme a un’elevata qualità dei materiali riciclati, ma anche a un controllo a livello di etica del lavoro e di tracciabilità.
Comprare meno e meglio
Lo svantaggio di questa modalità potrebbe essere il prezzo: procedure e controlli così curati aumentano a tal punto i costi da non poter competere con quelli della fast fashion. È chiaro quindi che, se un piumino di Save the Duck costa cinque volte un piumino di Zara, questo tipo di moda rimane una soluzione solo per chi se la può permettere.
Una moda sostenibile, però, sarebbe fondamentale per produrre capi di qualità e, soprattutto, per recuperare materiali di scarto che andrebbero a danneggiare l’ambiente e gli ecosistemi. Inoltre, potrebbe portare a una nuova consapevolezza anche da parte del consumatore riguardo l’etica del lavoro nel mondo della moda e potrebbe aiutare a far comprendere meglio quali siano le conseguenze reali di ciò che produciamo e indossiamo.
Oltretutto, potrebbe essere un buon modo per evitare, almeno parzialmente, la “gentrificazione dell’usato”: permetterebbe a chi vuole e chi può di comprare indumenti prodotti in modo sostenibile, lasciando a chi ne ha più bisogno la possibilità di comprare usato a un prezzo più ridotto. Allo stesso tempo, sarebbe un’opportunità per ripensare i nostri modelli di consumo, frenare l’impulso di comprare in grande quantità anche quando non se ne ha bisogno e, eventualmente, acquistare vestiti di qualità e durevoli: in poche parole, comprare meno ma comprare meglio.

Laureata in Giornalismo, Cultura Editoriale e Comunicazione Multimediale, ama viaggiare e conoscere culture e lingue. È interessata alla giustizia sociale e ambientale per aumentarne la consapevolezza.