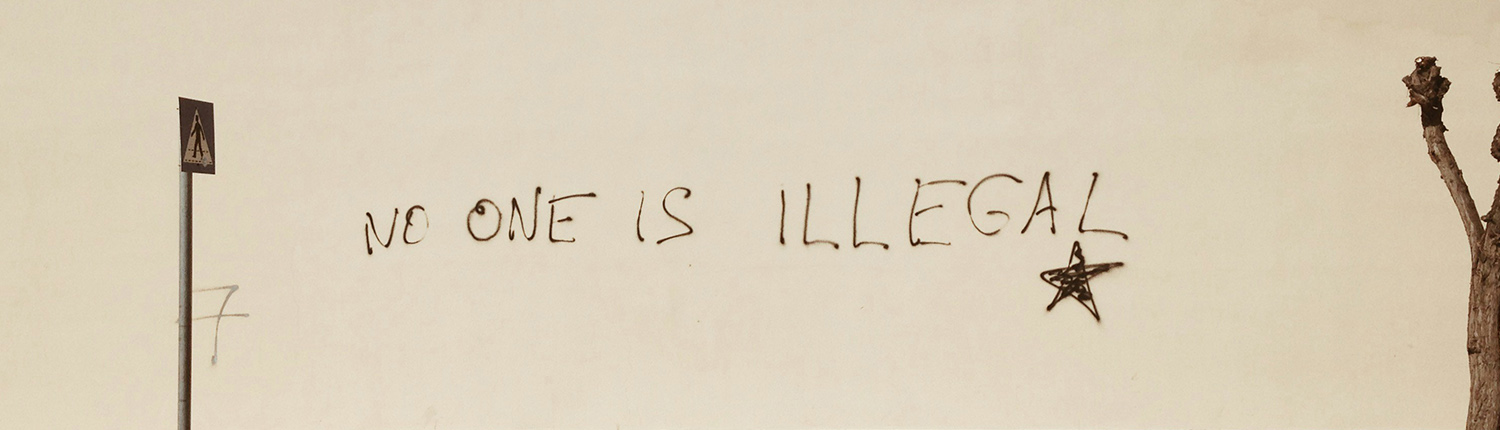Capitalismo, cultura e fast fashion
Come abbiamo già approfondito, il prezzo della fast fashion nella crisi climatica e globale non è più sostenibile. Se ancora ci ostiniamo a comprare da Topshop, H&M, Tezenis, Primark e in tutte quelle altre catene di vestiti che in maniera risaputa inquinano e sfruttano risorse e lavoratori significa che non prestiamo attenzione a ciò che ci circonda: ambiente, animali e altri esseri umani.
La fast fashion è uno degli ultimi baluardi della società dei consumi: alla base di essa si assume l’idea di produzione a risposta rapida invece che l’attenzione al prodotto finito. Zara è stato il marchio pioniere della rivoluzione fast, che procede per semplici step: copiare i grandi marchi di moda producendo in serie abiti simili a basso costo e invogliando così i consumatori a visitare più spesso i negozi di abbigliamento.
Ogni stagione questi shop ci presentano una quantità insostenibile di prodotti, pronti per essere acquistati, essere utilizzati un paio di volte per poi essere sostituiti la stagione successiva con qualcosa di nuovo. Compra, consuma e getta: reitera questo movimento all’infinito finché crepi.
Il dogma del consumo e della moda di massa è per certo necessaria determinazione ed implicazione della cultura capitalista che permea ancora vividamente il modo di vita dell’Occidente. Principalmente per ragazze e ragazzi è sinceramente difficile uscire dalla dinamica della fast fashion: sin da giovani crediamo di dover apparire in una certa maniera e di dover avere sempre abiti e scarpe all’ultimo grido.
Un cambio di rotta è necessario
In questo articolo per The Atlantic, Elizabeth Cline ritiene che gli Americani acquistino oggi una quantità di abiti cinque volte superiore a quella del 1980. A causa di questo aumento di consumo, i paesi ricchi stanno producendo ed esportando sempre più vestiti ad ogni stagione e questo comporta sia l’aumento dell’inquinamento causato dalla fast fashion che gli abiti smessi e scartati ogni anno.
Gli abitanti di New York, ad esempio, scartano circa 193.000 tonnellate di vestiti e tessuti, che equivale al 6% di tutta la spazzatura della città. L’Unione europea non è messa meglio, vista la produzione per un totale di 5,8 milioni di tonnellate di tessuti ogni anno.
La produzione di una nuova T-Shirt è strettamente legata al sovrasfruttamento delle risorse ambientali: per la precisione ci sono almeno due elementi non citati sull’etichetta del prodotto, il consumo di 2.700 litri d’acqua e 10 chili di emissioni di C02.
In tutte le fasi della produzione tessile, gli ecosistemi subiscono danni ambientali duraturi. Uno di questi effetti dannosi è il rilascio nell’aria di gas a effetto serra che, uniti ad altri fattori antropici contribuiscono alla destabilizzazione degli ecosistemi. Oltre al rilascio di gas pericolosi, vari pesticidi e coloranti vengono costantemente rilasciati nell’ambiente acquatico di ogni area in cui opera il settore della moda.
Quello che inoltre non c’è scritto sulla maggior parte degli abiti che acquistiamo e che poi velocemente buttiamo nella spazzatura senza pensare a chi li ha prodotti è che la manodopera che viene impiegata per questo è sfruttata e sottopagata, la maggior parte in paesi esteri carenti di diritti e di risorse.
Non è più possibile aspettare per un cambiamento di rotta: dal settembre 2020 un’installazione a Union Square a Manhattan – il climate clock – segna quanti anni, giorni, minuti e ore abbiamo ancora per scongiurare una irreversibile emergenza climatica.
Che fare?
Boicotta, riusa e scegli in maniera consapevole. È necessaria una presa di consapevolezza generale, ancor più dopo che le nostre vite sono state destabilizzate dalla pandemia. Un’abitudine che sta prendendo piede a partire dai periodi di lockdown generalizzati è comprare online e farsi recapitare a casa i pacchi, provare i vestiti e se non vanno bene rimandarli indietro.
Questa “post” fast fashion che non ci richiede nemmeno lo sforzo di uscire di casa per consumare è ancora peggio, ci rende ancora più automatizzati e inconsapevoli di ciò che facciamo: già le due tratte di andare avanti e indietro del fattorino che ci porta a casa il prodotto è un surplus inutile di inquinamento. Occorre riflettere sulle proprie azioni.
È necessario prendere posizione: non comprare se non è strettamente necessario (quante volte è strettamente necessario?), riusare, scambiarsi i vestiti, continuare ad usare ciò che abbiamo nell’armadio finché non è letteralmente inutilizzabile, fino a quando non è esaurito.
Quando occorre comprare, poi, bisogna farlo in luoghi in cui sappiamo cosa accade nella filiera di produzione, ci sono moltissimi brand, anche italiani, che lavorano in maniera sostenibile e che si impegnano per un futuro della moda in grado di soddisfare il valore del prodotto e del lavoro di chi lo produce.
Un’altra soluzione sostenibile è comprare nei negozi vintage che si propongono esattamente di non produrre ulteriori vestiti, utilizzare cose già prodotte per evitare un ulteriore sfruttamento delle risorse.

Laura sta per laurearsi in Filosofia all’Università di Padova. È appassionata di teatro greco antico e di filosofia contemporanea. È anche curiosa di Digital Marketing, in particolare quello che riguarda i Social Network. Felice di collaborare con una rivista che promuove uno stile di vita etico e sostenibile.