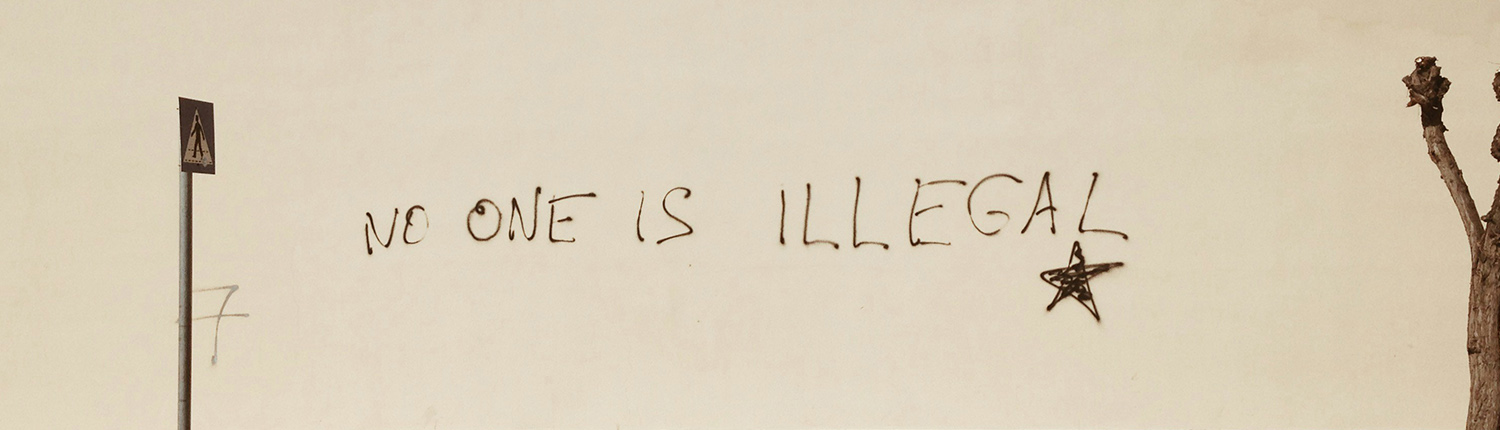La risposta di Slow Food
La risposta di Slow Food all’attuale sistema di produzione e consumo di cibo è tanto semplice quanto spiazzante: rallentare. Infatti, nel Manifesto di Slow Food, pubblicato per la prima volta dal Gambero Rosso il 3 Novembre 1987, possiamo leggere:
«Se la “Fast-Life” in nome della produttività, ha modificato la nostra vita e minaccia l’ambiente ed il paesaggio, lo “Slow Food” è oggi la risposta d’avanguardia».
Nel Manifesto, la “fast-life” è descritta come un virus che sta portando gli umani all’estinzione; la lentezza, d’altro canto, si presenta come l’unico vaccino possibile. Per realizzare un futuro in cui la biodiversità viene conservata, e la monocultura e agricoltura industriale contrastate, Slow Food propone di ripartire dalla tutela dei piccoli produttori locali e dei saperi tradizionali.
Per farlo, però, è necessario abbandonare il modello accelerato imposto dall’attuale industria alimentare. E dunque simbolo dell’intero movimento – e filosofia – di Slow Food non poteva che essere la slow lumaca. Oggi, questa chiocciolina rossa è diventata sinonimo di un cibo “buono, pulito e giusto”.
Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, di Luis Sepulveda
Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza (2013), racconto lungo dello scrittore Luis Sepúlveda, da poco venuto a mancare, vede protagonista una lumaca senza nome – «come del resto non lo avevano le altre lumache» – alla ricerca del significato della lentezza, condizione a lei intrinseca ma incomprensibile.
Durante il viaggio alla ricerca della sua identità, la lumaca della storia di Luis Sepulveda, si imbatte in una tartaruga, e proprio grazie a questo incontro riesce finalmente a comprendersi e apprezzarsi. In un passaggio che appare a noi quasi paradossale, la lumaca della storia di Luis Sepulveda si sorprende della velocità della tartaruga, facendoci realizzare quanto la lentezza sia sempre relativa. Non riuscendo a stare al suo passo, la lumaca della storia di Luis Sepulveda sale sul guscio della tartaruga:
«Così, mentre da lassù la lumaca vedeva passare le erbe del prato a una rapidità sconosciuta, la tartaruga le raccontò che veniva dall’oblio degli esseri umani».
La tartaruga era stata infatti abbandonata dai suoi padroni umani, perché troppo presi dalla loro vita veloce. Con questa storia Luis Sepúlveda ci ricorda che, scambiando l’efficienza con la frenesia, gli uomini hanno dimenticato il valore di dedicare tempo ai rapporti, coltivandoli con cura: l’incontro con l’altro può avvenire veramente – e quindi essere significativo – solo se gli si dedica il giusto tempo.
Un’idea di felicità
Proprio la storia della lumaca di Luis Sepulveda e l’amore per la lentezza hanno permesso un incontro: quello di Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food, e Luis Sepúlveda, nel libro Un’idea di felicità (2014). In questo testo, che è una conversazione e allo stesso tempo un manifesto per il futuro, Petrini afferma:
«Un altro dei pilastri su cui si fonda Slow Food è il diritto al piacere. Che si lega in maniera inscindibile con la lentezza: sono necessari l’uno all’altra».
Il diritto al piacere è infatti per Petrini un principio fondamentale e universale, che deve essere garantito a tutti. Proprio per questo, il piacere deve essere misurato, proporzionato, come la lumaca della storia di Luis Sepulveda. Luis Sepúlveda sottolinea infatti come la lumaca sia in molte culture simbolo di equilibrio, perché «ha lo spazio esatto in cui abitare, il suo esoscheletro: se deve crescere di due millimetri il suo esoscheletro cresce di due millimetri, non di più».
Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, nelle ultime pagine di Dialettica dell’Illuminismo (1944), parlano dell’antenna della chiocciola «dalla vista tastante, che le serve anche per odorare», come simbolo di una conoscenza che è situata corporalmente. Possiamo ritrovare questo tipo di sapienza in chi lavora tutti i giorni a contatto con il proprio territorio e i suoi prodotti, conoscendone profondamente i ritmi, sempre più lenti di quelli imposti dalla produzione intensiva.
A tutela di questa conoscenza, dei prodotti locali e dell’ambiente, Slow Food conta attualmente 644 Presìdi in tutto il mondo, di cui 369 in Italia, e promuove progetti come Terra Madre, una rete di agricoltori, pescatori, allevatori e produttori che si incontrano ogni due anni a Torino, al Salone del Gusto, per dialogare e confrontarsi sul tema della sostenibilità alimentare. Proprio la lentezza, così come viene espressa dalla lumaca della storia di Luis Sepulveda, rende possibile questo incontro internazionale di culture del cibo.
La lumaca di Slow Food, come quella di Luis Sepúlveda, ci insegnano dunque che la lentezza può diventare principio filosofico, valore di vita e risposta attiva per ripensare il sistema alimentare.
In sintesi: la lumaca della storia di Luis Sepulveda e Slow Food
Lo Slow Food è un movimento internazionale che promuove un’approccio più consapevole e sostenibile all’alimentazione. Fondato nel 1986 in Italia da Carlo Petrini, il movimento Slow Food si è diffuso in tutto il mondo e mira a contrastare la globalizzazione dell’alimentazione rapida (fast food) e promuovere una cultura del cibo più sostenibile, etica e salutare.
Il concetto di Slow Food si basa su diversi principi chiave legati alla sostenibilità alimentare:
- Biodiversità: Il movimento Slow Food si impegna a preservare la biodiversità e la varietà di piante, semi, animali e prodotti alimentari tradizionali. Valorizzando la diversità culinaria, si contribuisce a proteggere e conservare specie e razze locali a rischio di estinzione.
- Prodotti locali e di stagione: Slow Food promuove l’uso di ingredienti locali e di stagione per ridurre l’impatto ambientale legato al trasporto di cibo a lunga distanza e per sostenere l’economia locale.
- Produzione sostenibile: Il movimento sostiene pratiche agricole sostenibili, come l’agricoltura biologica e il rispetto per l’ambiente. Vengono promossi metodi di coltivazione rispettosi del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità.
- Diritti dei lavoratori: Slow Food sostiene condizioni di lavoro eque per i produttori e i lavoratori del settore alimentare, compreso il pagamento equo per il loro lavoro.
- Rispetto per gli animali: Slow Food promuove l’allevamento etico degli animali e il consumo responsabile di prodotti di origine animale.
- Educazione alimentare: Il movimento si impegna nella sensibilizzazione del pubblico attraverso attività educative, eventi e iniziative per diffondere una maggiore consapevolezza sui temi legati alla sostenibilità alimentare e alla cultura gastronomica locale.
L’approccio Slow Food incoraggia una connessione più profonda tra le persone, il cibo e l’ambiente in cui vivono. Valorizza l’importanza di prendersi il tempo per gustare e apprezzare il cibo, privilegiando la qualità, l’autenticità e l’impatto positivo sull’ambiente e sulla società.
Attraverso il suo lavoro, Slow Food contribuisce a promuovere pratiche alimentari più sostenibili, incoraggiando una maggiore responsabilità nel modo in cui produciamo, consumiamo e ci rapportiamo al cibo, nell’ottica di creare un futuro più equo ed ecologicamente sostenibile.

Laureata in Filosofia (UniBo), è attualmente studentessa magistrale di Environmental Humanities (UniVe). Si interessa di Critical Animal Studies, Etnografia Multispecie ed Ecocritica. Porta avanti un progetto di ricerca etnografica sulle conoscenze ecologiche tradizionali dei pescatori della laguna di Venezia.