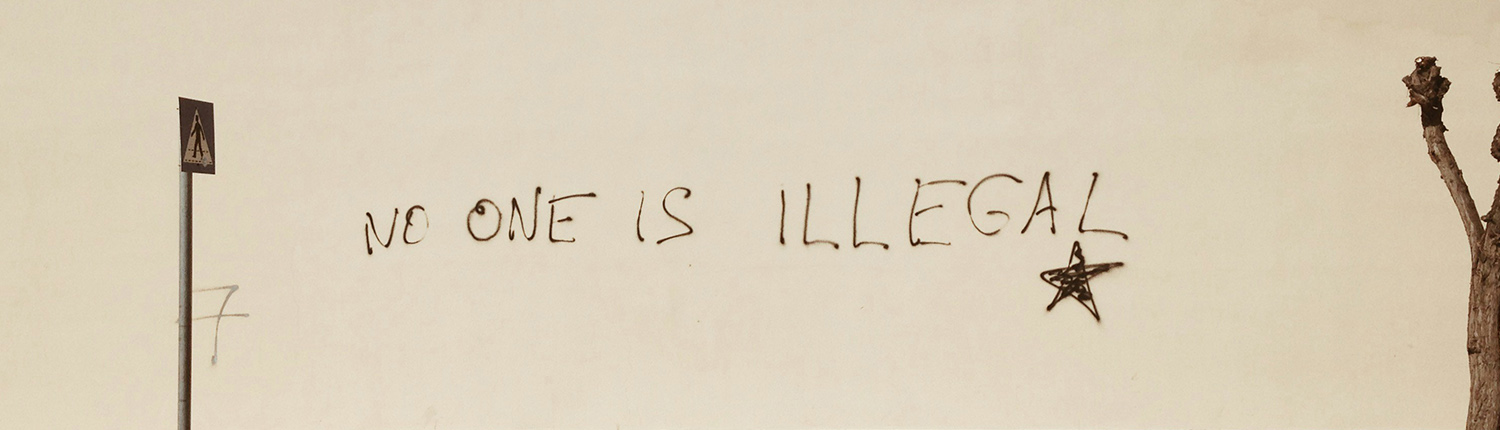Hibakujumoku: gli alberi sopravvissuti
Gli Hibakujumoku, anche noti come A-bombed trees, sono il lascito giapponese di quel tragico agosto 1945.
Con la commistione di Hibaku, che significa bombardato, e Jumoku, albero o bosco, il Giappone ha voluto dare una denominazione a quei vegetali che, dopo essere stati quasi annientati dalla devastazione delle bombe atomiche, hanno trovato lo spazio e l’energia per tornare a crescere.
Dove la vita faticava a ripartire, dove la morte sembrava avere il controllo sullo spazio e sul tempo, gli alberi hanno fatto forza sulle loro radici, tornando a germogliare rigogliosi.
Gli alberi sopravvissuti in Giappone sono circa 170 e appartengono a 32 specie diverse. Tra quelli censiti vi sono un Gingko Biloba, un pino nero giapponese (Pinus thunbergi) e un muku (Aphananthe aspera), incontrati e menzionati anche dal botanico italiano Stefano Mancuso, nel suo libro L’incredibile viaggio delle piante, di cui racconta e romanticizza: «alberi normali all’apparenza, se non fosse stato per l’evidente sentimento di rispetto e, direi, di affetto che suscitavano nelle persone che erano lì ad incontrarli.»
Per i locali, infatti, si tratta di un vero e proprio incontro con questi alberi, in quanto simbolo di un passato che ha portato una nazione sul baratro e l’umanità intera ad un confronto con la propria coscienza.
Stando agli studi condotti sugli effetti di quelle due prime bombe atomiche, le piante avrebbero sofferto solo sulle porzioni esposte e al di sopra del terreno, mentre le porzioni sotterranee e gli apparati radicali non sarebbero stati direttamente colpiti perché protetti dal suolo. Il dato che stupisce – e che è rilevante sottolineare – è che la potenza dell’esplosione in termini di calore rilasciato nei primi tre secondi di impatto è stato stimato essere pari a 40 volte quello del Sole. Nelle aree contigue all’epicentro la distruzione è stata totale, ma già ad alcune centinaia di metri sono sopravvissuti degli alberi, nonostante i danni subiti.
A circa 370 metri di distanza dall’epicentro è stato individuato l’albero sopravvissuto in assoluto più vicino all’esplosione: un salice piangente, e a circa 600 metri un albero della canfora, oggi, dopo quasi 80 anni, ancora vivi.
A-bombed tree: Albero della Canfora, 600 metri dall’epicentro, Nagasaki. Crediti: Katy McCormick, 2013
Resiliere
La resilienza, qui intesa come capacità di rispondere plasticamente a eventi più o meno traumatici, è ciò che spinge gli organismi a raggiungere un nuovo equilibrio una volta superate delle complicazioni, siano esse incendi, sbalzi termici, o, come in questo caso, una bomba atomica.
Gli ecosistemi sono in costante adattamento a queste forme di disturbo, che possono essere in parte provocate da eventi naturali e in parte dalle attività antropogeniche. Gli organismi vegetali, in quanto sessili, hanno dovuto necessariamente sviluppare delle capacità di risposta drasticamente diverse rispetto agli organismi animali che, da un qualsiasi disturbo, possono prendere le distanze.
La forza delle piante sta anche nella composizione cellulare: a differenza degli animali sono infatti dotate dei tessuti meristematici. Le cellule meristematiche sono caratterizzate da una preziosissima flessibilità: diventare quello di cui la pianta ha bisogno, al momento del bisogno. La flessibilità dei meristemi è fondamentale durante la germinazione del seme per differenziare quella che sarà la componente aerea e quella invece sotterranea, ma può avvenire anche nel mezzo della vita cellulare.
La duttilità di questi tessuti è di primaria importanza per lo sviluppo della pianta: contribuiscono alla faticosa crescita in altezza alla ricerca di luce, al ricambio fogliare, mantenendo la capacità di differenziamento. Anche grazie alla capacità dei meristemi di permettere la ricrescita dei tessuti danneggiati, le piante hanno sviluppato e continuano a sviluppare meccanismi di resilienza sorprendenti.
Cos’hanno in comune Hiroshima e la minaccia climatica?
In seguito all’esplosione atomica di Hiroshima e Nagasaki è circolato un percettibile e giustificato senso di vulnerabilità tra gli abitanti sopravvissuti. Come riporta Robert Jay Lifton in uno dei suoi più noti studi-intervista, dal titolo Death in Life: Survivors of Hiroshima, la paura che circolava per la maggiore era relativa alla vegetazione e al suo ritorno alla normalità. Sarebbe mai ricresciuta l’erba?
Sarebbero mai sbocciati altri fiori? Il sentimento di desolazione e abbandono caricò l’atmosfera di pesanti frustrazioni e timori, probabilmente dovuti, in parte o completamente, ad effetti più o meno ritardati delle radiazioni, giustifica Lifton.
Ma con il passare del tempo le piante ripresero a germogliare, l’erba a crescere, i ciliegi a sbocciare. Persino gli animali tornarono, dopo una lenta ripresa, in un luogo che sembrava loro favorevole e prolifico.
Secondo alcuni, la crisi climatica non è altro che una bomba atomica con effetti protratti per un più lungo periodo di tempo.
Gli Hibakujumoku sono la prova vivente che nonostante l’essere umano abbia raggiunto la capacità di estinguersi con le proprie creazioni, le montagne persisteranno nella loro maestosità, i fiumi continueranno a scorrere lungo le valli, le foreste continueranno a respirare nella loro paziente crescita.
Bibliografia
- R.L. Lebow, Hiroshima and Nagasaki: The Physical, Medical, and Social Effects of the Atomic Bombings, in «Naval War College Review», vol. 35, 1982, n. 4 July-August: https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol35/iss4/15.
- J. Lifton, Death in Life: Survivors of Hiroshima, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1991.
- Mancuso, L’incredibile viaggio delle piante, Roma, Laterza, 2018.
- Rhodes, L’invenzione della bomba atomica: 6 agosto 1945 : l’inizio di una nuova era, Milano, Rizzoli, 2005.

Laureata in Scienze Ambientali e studentessa di Environmental Humanities presso Ca’ Foscari. Appassionata di ambiente, di innovazione e di comunicazione.