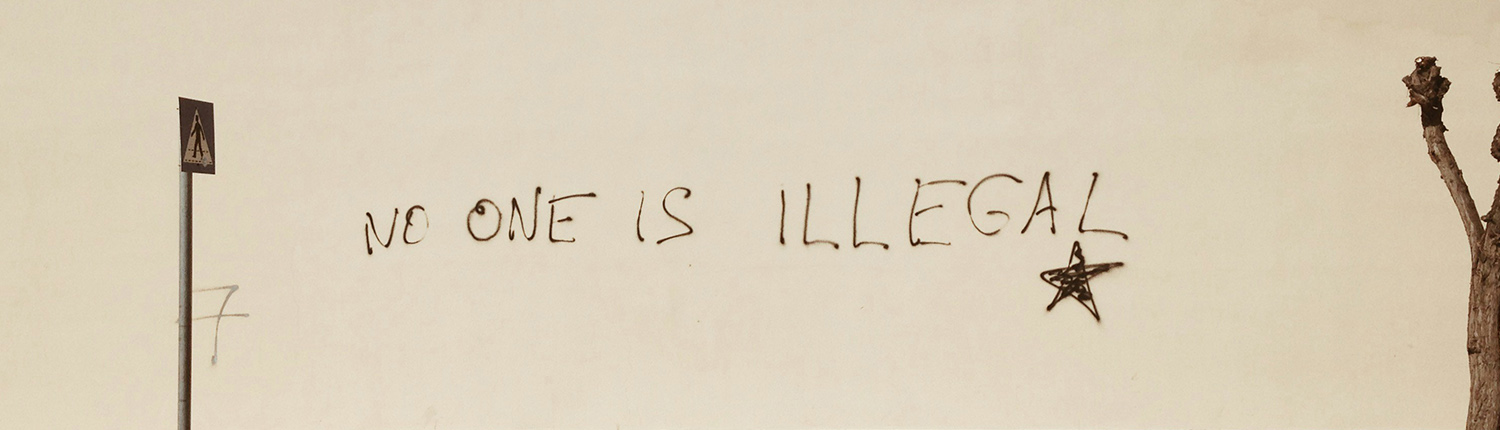Ecosistemi e società
I presupposti per un pensiero sostenibile
Una riflessione sul mondo vegetale
Al giorno d’oggi è sempre più usuale imbattersi nel termine sostenibilità, risultato della crescente sensibilità nei confronti dell’ambiente e della sua stretta interrelazione con lo sviluppo. Ma quali sono i modi in cui è necessario concepire la realtà perché il nostro pensiero sia realmente sostenibile?
Aderendo a una certa inclinazione antropocentrica, siamo abituati a rappresentarci mentalmente una netta divisione tra il mondo umano e quello naturale, ma i recenti avvenimenti ci hanno costretto a prestare maggiore attenzione al legame (non così pacifico) tra queste due realtà.
Uno studio molto interessante su questo tema è stato condotto fin dai primi anni ’90 da Suzanne Simard, una biologa canadese che ha dedicato la propria vita all’osservazione delle dinamiche caratterizzanti il mondo vegetale. Ed è a partire dalle sue ricerche che tenteremo di comprendere meglio i rapporti che contraddistinguono l’ambiente naturale e di compararli con quelli specifici del milieu umano, al fine di mostrare che non è possibile tracciare una vera e propria differenza tra questi due mondi.
La rete simbiotica degli ecosistemi
Una delle dinamiche fondamentali che sono alla base della regolamentazione dei rapporti tra microrganismi è la simbiosi, una relazione di mutuo beneficio. L’esempio più evidente è quello delle micorrize, che sono «associazioni simbiotiche tra funghi e piante, strette in un rapporto fisiologico, ecologico e riproduttivo».
Simard, dopo aver analizzato il DNA delle radici e tracciato il movimento delle molecole attraverso condotti sotterranei, comprese che questi “fili” di organismi connettono tutti gli elementi della vegetazione di una foresta, anche se appartenenti a specie differenti. Si tratta di una stretta interdipendenza tra ogni pianta, che dà e riceve nutrimento e informazioni.
Tra gli scienziati è usuale considerare questa rete di scambi come il modo in cui gli alberi si esprimono tra loro: «le piante comunicano attraverso la rete micorrizica in modo simile ai pensieri che viaggiano sulla rete di neuroni del cervello». Questo paragone è piuttosto efficace, in quanto tale struttura reticolare è dotata di una vera e propria attività cognitiva, in grado di apprendere, ricordare e riconoscere il diverso da sé.
Queste interazioni mutualistiche e cooperative tra organismi diversi sono alla base del funzionamento degli ecosistemi, formati dunque da un intreccio di relazioni e di scambi reciproci. Una tale scoperta mina alla base l’oggi ampiamente condivisa concezione darwiniana del mondo naturale (fondata – almeno apparentemente – sulla competizione e sulla lotta per la sopravvivenza) e la integra con una visione cooperativa della natura.
La contrapposizione natura/società
Nonostante il pensiero e le analisi di Darwin siano estremamente complesse, il meccanismo che ne è emerso è di tipo individualista e si è inserito perfettamente nella concezione contemporanea della realtà: non una variazione in termini di “popolazione”, ma di “unità”.
Ciò ha condotto a pensare il vincolo fondamentale tra gli esseri viventi come un rapporto di competizione, una contrapposizione tra i singoli individui che innesca una lotta per la sopravvivenza. Se si accoglie questa struttura di funzionamento del mondo, si è necessariamente portati ad accettare una netta contrapposizione tra natura e società.
Inizialmente il dialogo tra questi due poli opposti è stato impostato su una relazione di sfruttamento: la società, intesa quale insieme di individui, utilizza la natura per la propria sopravvivenza e il proprio progresso, come se fosse qualcosa di totalmente altro da essa.
Ovviamente si tratta di una banalizzazione di ciò che è effettivamente la realtà, ma questo spiega l’impostazione del pensiero sostenibile esplicitato nel rapporto della Commissione mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1987, in cui ci si è occupati seriamente per la prima volta delle tematiche ambientali.
Per esempio, in questo documento lo sviluppo sostenibile è definito come «lo sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie». Nello stesso rapporto lo spazio ambientale è descritto come «la capacità delle funzioni ambientali della biosfera di sostenere le attività economiche umane».
In questi esempi è evidente il tentativo di regolamentare la sensibilità verso l’ambiente in cui viviamo, ma la forma mentis da cui emerge questa coscienza ecologica è sempre informata da una contrapposizione di fondo tra natura e società. L’atteggiamento può essere sia di sfruttamento sia di tutela, ma è innegabile che l’uomo si sia posto di fronte alla natura quale suo padrone e pretenda di amministrarla.
Un nuovo pensiero sostenibile
Ovviamente non è possibile stabilire con esattezza come sia effettivamente strutturata la realtà, ma senz’altro la scoperta dell’organizzazione del mondo vegetale in una rete micorrizica a nodi apre a un’altra possibilità. Se il principio regolatore della natura non è più eretto sulla competizione ma sulla cooperazione, allora è possibile smantellare la summenzionata visione odierna della realtà.
Così come ogni albero non deve più lottare per sopravvivere, ma può appoggiarsi su una rete di nutrimento condivisa, così l’uomo non deve più necessariamente pensarsi in un’ottica di estrema competizione con gli altri individui e può progettare la sua vita in correlazione con gli altri e con l’ambiente.
Un pensiero sostenibile autentico dovrebbe contemplare l’uomo e la società come immersi nella natura in un rapporto di totale ibridazione. Non si tratta più di abusare o di prendersi paternalisticamente cura di un sistema ambientale altro, ma di rendersi conto di essere parte del mondo e di potere e dovere cooperare con gli esseri viventi che occupano i nodi della rete a fianco a noi sviluppando un rapporto di reale simbiosi mutualistica.
Suggerimenti di lettura
- Peter Wohlleben, La vita segreta degli alberi
- Bruno Latour, Non siamo mai stati moderni

Dottoranda in Filosofia (Unipd) si occupa di Arte e Intelligenza Artificiale. Interessata al rapporto tra Natura e Cultura, si occupa della Redazione di Atmosphera Lab.