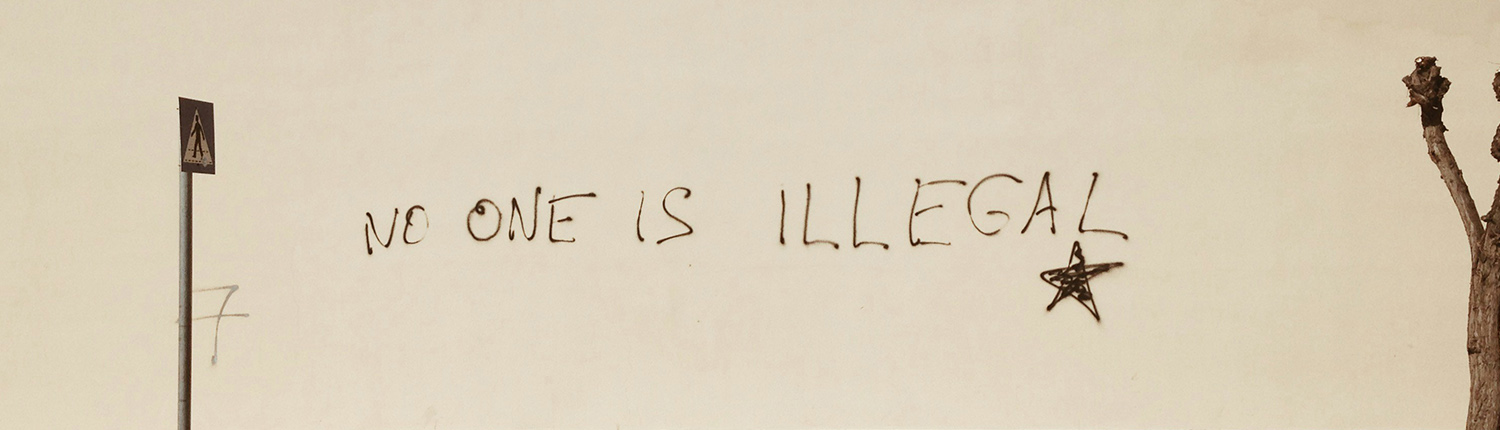L’orto online
É difficile non aver mai provato, o almeno visto o sentito nominare, quei giochi in cui è possibile creare una fattoria virtuale, con orto, animali, eccetera. Forse, una persona ignara che si imbatte nel sito di MyAgry potrebbe pensare che si tratti esattamente di questo. “Porta la campagna a casa tua”, recita una grossa scritta in cima alla pagina; e subito sotto, “crea il tuo orto”, “crea il tuo uliveto”. Se provasse, tuttavia, a seguire il link, scoprirebbe che, una volta selezionate una serie di colture, tendenzialmente verdure, e posizionate su dei quadratini simboleggianti il terreno, si andrebbe a un checkout che chiede un pagamento.
Questo perché MyAgry non crea fattorie o orti virtuali: quelle colture verranno piantate veramente, in orti fisicamente esistenti, da esperti agricoltori, che, per di più, sono dediti all’uso di metodi biologici e tradizionali.L’obiettivo è fornire prodotti sani e stagionali a chi vive in aree urbane e progettare la coltivazione insieme al consumatore, che è informato di ogni passaggio e può dunque avere una visione “interna” del lavoro. In altri termini, viene sfumata quella linea che, nella filiera tradizionale, separa nettamente produttore e consumatore.
Nuove tecnologie per vecchie idee
Questa idea non è, in realtà, del tutto nuova:negli anni ‘60, in Giappone si verificarono numerosi scandali di contaminazione alimentare.Molte persone subirono danni permanenti acquistando i prodotti della grande distribuzione, alla cui origine era difficile risalire e sulla cui qualità vi erano ben pochi controlli. Cominciarono dunque a contattare direttamente piccoli agricoltori locali, magari biologici, cercando cibo di qualità da una relazione costruita soprattutto sulla fiducia reciproca. Tutto questo prese il nome di Teikei, “cooperazione” in giapponese.
Questa volontà e necessità di tornare a vedere e sperimentare in prima persona l’origine del cibo che ci si trova sulla tavola quotidianamente trovò spazio anche in altri paesi.
In Svizzera, nel 1978, un gruppo di cittadini e un agricoltore iniziarono a collaborare, gestendo di accordo comune vari orti. Nacque così Les jardins de Cocagne, tutt’oggi presente. Non si tratta, dunque, solamente di un gruppo di cittadini e cittadine che sceglie di acquistare direttamente dal produttore; bensì, la cittadinanza assume un ruolo di partecipazione attiva nella produzione. La pianificazione è comune e la coltivazione collaborativa.
Oggi, la Community Supported Agriculture, o anche comunemente CSA, come è definita in inglese, si è diffusa in tutti i continenti. Il movimento che si ispira a questi principi conta ormai varie associazioni sia a livello nazionale – come Solawi in Germania, CAFF negli Stati Uniti, o CSA Brasil – che a livello internazionale, come Urgenci.
E in Italia?
In Italia, questo modello ha avuto qualche difficoltà a diffondersi. Certo, i GAS (Gruppi Acquisto Solidale) possono essere ritenuti un’iniziativa con numerose affinità con la CSA. All’esperienza dei GAS manca tuttavia completamente la componente di partecipazione del cittadino all’attività produttiva, sia in termini di pianificazione che in termini di presenza fisica sul campo.
Esistono, comunque, alcuni esempi di discreto successo, come Arvaia a Bologna o Semi di Comunità a Roma. Una ricerca del 2021 evidenzia come il modello della CSA, per come è realizzato in Italia, rispetta tutti i criteri di sostenibilità necessari a un’agricoltura del futuro; tuttavia, il livello di partecipazione e la sostenibilità finanziaria variano molto. Questo problema è aggravato dalla mancanza totale di un quadro normativo per questo tipo di attività. Altri punti critici che vengono spesso sollevati sono l’inclusività, nel senso dell’insostenibilità economica della partecipazione per moltissime famiglie, e la difficoltà nel raggiungere un pubblico non già sensibilizzato e interessato.
In questo senso, MyAgry potrebbe facilitare la diffusione di un diverso modello produttivo eliminando la necessità di essere vicino al luogo in cui si trova la CSA; rimane l’interrogativo dell’efficacia dell’educazione del cittadino rispetto alla necessità di un’agricoltura diversa nel mezzo digitale, in mancanza di presenza fisica. Sicuramente, comunque, è un’iniziativa che va nella giusta direzione, cioè quella del cambiamento dei pattern di consumo e di responsabilizzazione e presa di coscienza della cittadinanza.

Lombarda, laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università Statale di Milano, frequenta attualmente il corso di laurea magistrale in Environmental Humanities all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Sviluppata una sensibilità verso le questioni ambientali e sociali in vari periodi di studio e volontariato all’estero e in Italia, ha deciso di dedicarvisi sia con lo studio che con la divulgazione, collaborarando con AtmospheraLab.